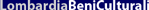Introduzione
1. La storia
1.1. Il monastero del Salvatore
Il monastero di S. Felice, situato presso l’antica porta Marenga, nella zona occidentale di Pavia, era sede di una comunità di benedettine [1]. Soppresso nel 1785 per volontà di Giuseppe II [2], i suoi locali vennero ristrutturati dal Pollach [3] ed adibiti ad orfanatrofio nel 1792 [4]. Attualmente il monastero è sede della Facoltà di Economia e Commercio nonché dell’Istituto di Psicologia e della Sezione Filosofico-Teorica del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pavia.
La data di nascita dell’ente non è positivamente conosciuta, perché non è pervenuto il documento di fondazione: tant’è che alcuni storici pavesi, ispirandosi a leggende o formulando congetture poco persuasive, attribuirono il ruolo di fondatore chi ad un s. Felice martire (III sec. d.C.) [5], chi a re Liutprando [6]. In realtà sembra ormai appurato che la fondazione del cenobio sia da ascrivere al re longobardo Desiderio ed alla moglie Ansa, come attestano due diplomi regi concessi al monastero di S. Salvatore di Brescia, anch’esso fondato dalla medesima famiglia reale ed oggetto precipuo delle sue cure [7]. Il 4 ottobre 760, infatti, i due sovrani, insieme al figlio Adelchi, confermano a S. Salvatore “senodochium quidem nostrum quod intra civitatem nostram Ticinensem … hedificavimus ubi et basilicam in onorem Dei genitricis Marie et sanctorum apostolorum Petri et Pauli construximus” [8]. Nel preceptum successivo, dato a Brescia il 771 luglio, Desiderio conferma al S. Salvatore di Brescia nonché al monastero “quod intra muro civitatis nostrae Ticino ad nobis et ad suprascriptam coniuge nostram constructum in honore domini Salvatoris atque omnium apostolorum et sancti Danihelis” [9] i diplomi di Adelchi ed Ansa che gli erano stati presentati. I problemi che nascono da un esame comparativo dei due diplomi sono di due ordini: innanzitutto è necessario stabilire se la basilica della prima concessione ed il monastero della seconda, diversamente intitolati, siano i medesimi enti; quindi, mancando nelle dedicazioni sopra citate la benché minima allusione ad un s. Felice, restano da indagare i legami che intercorrono fra l’organismo di fondazione regia ed il monastero pavese. La prima questione mi sembra intuitivamente risolvibile, poiché le due istituzioni citate presentano ineludibili analogie: entrambe sono site in Pavia, fondate dai medesimi sovrani, dipendenti o comunque legate al S. Salvatore di Brescia, dedicate agli apostoli. I rapporti fra l’istituzione attestata nei diplomi di Desiderio ed il ‘nostro’ cenobio si chiariscono invece alla luce dell’intitolazione al Salvatore, che, essendosi conservata, unica fra quelle sino ad ora menzionate, nei secoli successivi [10] ed avendo affiancato quella nuova a s. Felice (che apparirà solo nel 1001; cf. doc. n. 2) costituisce il trait-d’union fra i due enti.
La presenza originaria di molteplici intitolazioni, alcune delle quali utilizzate solo una volta, non deve stupire: la ritroviamo per esempio anche nel caso del S. Salvatore di Brescia, inizialmente dedicato ai santi Michele e Pietro [11]. Inoltre, e forse non è solo una mera coincidenza, l’originaria dedicazione a s. Pietro ritornerà nel nome di una cappella detta “S. Petri adpodiati”, ovvero “S. Petri de S. Felice” [12], collocata vicino a S. Felice (di qui l’aggettivo “adpodiatus”) e da esso dipendente. Benché la cappella sia attestata nei documenti solo a partire dai primi anni del secolo XIII, non possiamo escludere che la sua fondazione fosse più antica.
La dedicazione al Salvatore, sebbene sia per noi prezioso elemento chiarificatore, in realtà ha anche contribuito a creare fra gli storici una certa confusione a proposito dell’identificazione, fondazione e datazione dell’ente. Il caso più clamoroso è forse rappresentato dall’opera del Pessani [13]. Lo studioso pavese, infatti, rifacendosi ad un passo di Paolo Diacono ove si narra che Liutprando: “intra suum quoque palatium oraculum domini Salvatoris aedificavit, et, quod nulli alii reges habuerant, sacerdotes et clericos instituit, qui ei cotidie divina officia decantarent” [14], asserì che, a motivo della comune intitolazione, l’oraculum poteva identificarsi con S. Felice. La sua collocazione all’interno di un edificio regio era facilmente spiegabile ipotizzando l’esistenza di un palatium suburbano [15], ubicato presso S. Pietro in Ciel d’Oro nelle cui vicinanze si trovava anche S. Felice. In realtà l’esistenza di un secondo palazzo reale [16], mai suffragata da sufficienti dati storici, fa parte di quei “miti” della storiografia pavese duri a morire benché ampiamente confutati [17]. In realtà, l’ipotesi di una fondazione da parte di Liutprando perde ogni fondamento alla luce dei documenti di Desiderio ed Ansa, mentre la dedica al Salvatore è facilmente spiegabile adducendo il rapporto di dipendenza che legava il monastero pavese a quello bresciano.
1.2. Il monastero della Regina
Nel nono secolo il futuro S. Felice compare in quattro diplomi regi ed imperiali, ma ancora una volta sotto nuova denominazione.
In data 851 settembre 8 Lotario e Ludovico II confermano a Gisla, rispettivamente sorella e figlia, il monastero di S. Salvatore di Brescia con le sue dipendenze: fra queste è menzionato un “monasterium in Papia qui vocatur Regine” [18]. Si tratta ancora una volta di S. Felice, celato sotto diverso nome ma riconoscibile, poiché, come il precedente, sito in Pavia e dipendente dal cenobio bresciano. Il nuovo appellativo si manterrà per poco meno di tre secoli: accompagnato, a partire dal 1001, e gradualmente soppiantato dall’intitolazione a S. Felice, lascerà l’ultima traccia di sé in una carta privata del 1128 conservata nell’archivio del monastero [19].
Nell’868 aprile 28 Ludovico II concede alla moglie Angelberga il “monasterium in Papia quod vocatur Reginae”, insieme ad uno “xenodochium Sanctae Mariae in Papia situm quod dicitur S. Maria Britonum” [20], che sembra ricondurci allo xenodochio menzionato nel primo diploma di Desiderio ed Ansa [21]. Ancora, in data 889 giugno 12 Arnolfo re conferma alla stessa Angelberga, ormai vedova di Ludovico, nonché alla di lei figlia Ermengarda il “monasterium Regine” [22] unitamente ad altri beni fra cui spicca il sempre presente S. Salvatore di Brescia, ora chiamato “monasterium Novum” [23]. Infine, nell’891 febbraio 21 Guido imperatore dona alla moglie Ageltrude il “monasterium Reginae in honore sanctae Dei genetricis Mariae constructum”, talvolta chiamato anche “abbatia” [24].
Nella seconda metà del secolo IX l’intitolazione al Salvatore non viene mai menzionata, ed il monastero è individuato solamente dall’appellativo “Regine”. Interrogarsi sulle caratteristiche dell’istituzione in questo periodo, domandarsi se le sue strutture fossero le medesime che in età longobarda equivale, allo stato attuale delle ricerche, a non ottenere una risposta soddisfacente. I reperti archeologici che S. Felice mette a nostra disposizione hanno dato adito a diverse congetture. L’Arslan fu tra i primi a riconoscere elementi riconducibili all’VIII secolo nella fiancata dell’edificio [25]. Secondo il Peroni [26] la chiesa, costruita ad aula unica triabsidata come l’oratorio di S. Michele alla Pusterla e la cripta di S. Maria alle Cacce, entrambi dell’VIII secolo, nella sua fase più antica, che interessa la parte orientale, è databile anteriormente all’851 [27]. La Vicini non esclude la presenza di un impianto longobardo a livello planimetrico [28]. Hudson, infine, rifacendosi ai diplomi del secolo VIII, afferma che “la cripta e l’abside, un tempo attribuite ad un’epoca anteriore all’851 … dovrebbero forse invece essere assegnate alla fase finale dell’architettura longobarda, come era stato proposto dall’Arslan” [29]. Gli studiosi sembrano dunque concordare su una datazione approssimativa della chiesa; tuttavia manca ancora uno studio approfondito che possa rendere conto delle diverse fasi costruttive e dell’evoluzione dell’edificio attraverso i secoli. I dati forniti dai documenti ci permettono solamente di affermare che i re carolingi ed i re d’Italia si interessarono al monastero, concedendolo di volta in volta a mogli, sorelle, figlie, ed attestando nelle loro concessioni la nascita di un appellativo non documentato in precedenza. È pertanto auspicabile che in futuro nuovi studi storico-artistici ed archeologici contribuiscano a gettare luce sulla storia più antica dell’edificio.
Quelli relativi alle vicende materiali non sono però i soli problemi che il monasterium Regine ci regala: il suo stesso nome è un mistero, perché ignota è la regina cui si riferisce. Per rendere ragione dell’appellativo, gli storici hanno formulato diverse ipotesi. La spiegazione più plausibile fra quelle avanzate, anche se non suffragata da alcuna testimonianza, è forse quella fornita da Robolini e ripresa da Maiocchi [30]: l’avvenuta fondazione del cenobio ad opera della regina Ansa, impressa nella memoria collettiva popolare, avrebbe originato l’appellativo “Regine”. Non convince invece completamente l’interpretazione dell’Hudson [31], che considera l’appellativo “Regine” apposizione di “Mariae”; infatti nel diploma dell’891 sopra citato, che fra l’altro è l’unico in cui i due vocaboli appaiano accostati, non emerge affatto una stretta correlazione che permetta di riferire il titolo di Regina alla madre di Cristo. È infine opportuno ricordare qui una leggenda che alcuni studiosi ambientano nel monastero della Regina [32]: attorno all’888 Etelswith, consorte di re Burgred di Mercia, recatasi in Italia e successivamente morta in Pavia, sarebbe stata forse sepolta nel cenobio. Nulla si può dire riguardo alla veridicità o meno di tale leggenda, tuttavia, anche supponendo, con le dovute riserve, l’esistenza di antiche spoglie regali nel monastero, non se ne ricavano elementi utili per giustificare l’appellativo “Regine”, già attestato, come abbiamo visto, nell’851: oltre trenta anni prima dell’arrivo della sovrana britannica.
Dello “xenodochium … quod dicitur S. Maria Britonum” citato nel diploma di Ludovico II [33] si persero ben presto le tracce. Lo menziona il Gianani [34] riferendo che “anticamente a Pavia c’era un hospitale S. Marie Britonum”. Il titolo di “hospitale” si giustifica con il fatto che gli xenodochia, nati come “organismi economici che permettevano ai grandi produttori di mantenere in loco i rapporti di commercio” fungevano anche da ricovero e da ospizio [35]. Il nome di S. Maria Britonum lascerebbe intuire la presenza di un ospizio per i Bretoni, o forse meglio per i Britanni [36], e comunque è indice “di interessi commerciali di enti religiosi dell’Europa occidentale” [37].
Nell’ultimo diploma che ho citato, dell’891, per la prima volta non si fa parola del S. Salvatore di Brescia, e non è un caso, poiché da questo momento in poi le vicende dei due monasteri di comune fondazione si separeranno.
1.3. Il monastero di S. Felice
Nell’ottobre del 1001 [38], durante un placito a cui presenzia Ottone III, la proprietà del monastero “in honore domini Salvatoris et sancti Felicis et vocatur Regini” viene rivendicata da Lanfranco avvocato dell’imperatore e del Regno contro le pretese della contessa Rolinda, figlia del defunto re Ugo, e di suo figlio Uberto diacono.
L’ultima intitolazione in ordine di tempo, che nel giro di poco più di un secolo diventerà intitolazione definitiva e rimarrà tale sino alla soppressione dell’ente, è forse quella che pone il maggior numero di problemi. Infatti l’inusuale esistenza di tre denominazioni principali, accavallatesi nel corso di quasi tre secoli, impedì agli storici di riconoscere l’unicità del monastero nelle diverse fasi della sua vicenda. Pertanto, non identificando il cenobio di fondazione longobarda, e talvolta neppure il “monasterium Regine”, con il S. Felice da essi conosciuto, nel tentativo di chiarirne la fondazione gli studiosi accreditarono numerose leggende che, innestatesi l’una sull’altra, crearono grandi fraintendimenti.
La prima leggenda, ormai ampiamente smentita, è quella che vorrebbe fondatore del monastero un s. Felice martire e vescovo, cui sarebbero appartenute le reliquie conservate nel cenobio sino alla sua soppressione. Di un corpo “s. Felicis episcopi Spelatensis” sepolto nel “monasterium S. Felicis episcopi et martiris” parla infatti la più antica fonte attendibile relativa all’argomento [39], senza però identificare il santo con il fondatore dell’istituzione. Sarà il Gualla che, riprendendo la vicenda del vescovo di Spalato, vi aggiungerà inediti particolari: martirizzato “Tarquino imperante”, avrebbe fondato la “basilica ubi quiescit”, successivamente a lui intitolata, dedicandola al Salvatore [40]. Il Breventano [41], nel descrivere le reliquie conservate nel monastero, parla delle spoglie di un “Felice vescovo spalatense e martire da cui poi la detta chiesa ha preso il nome”, senza tuttavia alludere alla fondazione. Con il Bossi [42], però, le cose si complicano, perché il martire di Spalato diventa anche nono vescovo di Pavia, cosicché la strada è spianata al Ghisoni [43] che può affermare: “extructa primitus aedes fuerat a S. Felice Spalatense, episcopo Ticinense, circa annum 253”. In realtà l’esistenza di un s. Felice antico vescovo di Pavia, già messa in dubbio dal Capsoni e dal Robolini [44], non è neppure presa in considerazione dal Savio e dagli studiosi più recenti [45], i quali, accusando gli eruditi locali di avere deturpato la realtà storica, restituiscono una più credibile cronologia degli antichi vescovi pavesi.
La tesi di una fondazione risalente al III secolo è comunque invalidata dalla presenza dei diplomi di Desiderio ed Ansa, in cui i due sovrani affermano di aver edificato il monastero, nonché dal fatto che la prima menzione dell’intitolazione a s. Felice è di ben settecento anni più tarda. Ipotizzare che un vescovo di Spalato chiamato Felice abbia costruito un edificio in Pavia, sulle cui fondamenta successivamente i re longobardi hanno fondato il loro monastero, ospitando le spoglie del santo che però inspiegabilmente cominciano ad essere menzionate solo nel secolo XI, è alquanto improbabile. L’unica parte accettabile della leggenda è quella che colloca nella chiesa le reliquie di un s. Felice di origine spalatense, pervenute al monastero in epoca imprecisata ed a causa delle quali il cenobio assunse poi la denominazione definitiva.
Nel placito del 1001 la ripresa della dedicazione al Salvatore e soprattutto la nuova dedica a s. Felice, nonché il rinnovato interesse imperiale [46], sono elementi che lascerebbero supporre per lo meno l’afflusso di nuove reliquie al monastero, e forse anche un rinnovamento materiale dell’istituzione [47]. I documenti ufficiali, estremamente scarsi, tacciono in proposito. Le conclusioni degli storici dell’arte, invece, sembrerebbero suffragare l’ipotesi di una rifondazione o ristrutturazione dell’ente: infatti dopo la prima fase di costruzione, attribuibile, come abbiamo visto, all’epoca tardo-longobarda, ne è stata individuata una seconda, localizzata nella parte occidentale della chiesa, che si potrebbe ascrivere, sempre con le dovute cautele, all’età ottoniana [48].
Dal canto loro, le fonti locali sembrano concordare in tutto e per tutto con le affermazioni degli storici dell’arte: cataloghi, compilazioni, iscrizioni e historiae testimoniano all’unisono un intervento di Ottone II a favore degli edifici del complesso monastico. In realtà, il problema è molto più complesso di quanto tale concordanza lascerebbe suppore: un esame approfondito delle fonti pavesi ci rivela che le loro informazioni non possono essere facilmente accettate.
Le testimonianze più antiche concordano nel ritenere il monastero stesso edificato da un Ottone: così, per esempio, il Catalogo Rodobaldino [49]: “In ecclesia dicti monasterii facti per Ottonem Theutonicum regem…”, e così anche, con nuovi particolari, una lapide, ora murata in una parete della chiesa di S. Felice, restaurata nel 1611 e copiata “nil mutato” da una anteriore stimata dal Robolini “niente più antica del secolo XIV” [50]: “ecclesia primitus S. Salvatoris appellata que ob reverentia s. Felicis ibidem quiescentis fuit postmodum nuncupata et per sanctum Maiolum abbatem ad instantiam serenissimi imperatoris Ottonis secundi in monasterii fabrica S. Felicis monialium ordinis s. Benedicti aucta et ampliata ac multis privilegiis honorifice dotata” [51]. Fin qui è mantenuta una chiara distinzione fra il monastero edificato da Ottone e la chiesa semplicemente ristrutturata. Tuttavia gli storici successivi, male interpretando le fonti più antiche, confonderanno le acque e parleranno di una fondazione ottoniana non solo del monastero ma anche della chiesa: inaugurerà questa tendenza il Gualla, contraddicendo tra l’altro l’ipotesi da lui stesso enunciata dell’edificazione ad opera di s. Felice [52]. Lo stesso Gualla definisce le monache “ab imperatore ipso multisque aliis praevilegis amplissimis dotatae”. Emulando il Gualla, sia il Breventano [53] sia il Bossi [54] parleranno di un “tempio” costruito o voluto da s. Maiolo in concordanza con i desideri dell’imperatore, mentre il Ghisoni, qui più accorto [55], specificherà che la chiesa venne solamente riedificata dall’abate cluniacense per volontà di Ottone, mentre “quando … erectum inibi fuerit sanctimonialium gyneceum … nihil asserere audemus”. Sempre il Ghisoni colloca, questa volta arbitrariamente [56], la ricostruzione della chiesa in concomitanza con un episodio storico: l’incontro, avvenuto in Pavia nel dicembre 980, fra Ottone II e la madre Adelaide che nella città ricomposero i loro dissidi grazie all’intervento di s. Maiolo [57].
Le fonti più antiche concordano dunque nel proporre una costruzione ex novo del monastero operata da un Ottone (ricordo infatti che il Catalogo Rodobaldino non specifica di quale Ottone si tratti); le fonti più recenti invece attribuiscono variamente la fondazione o riedificazione della chiesa e/o del monastero ad Ottone II e s. Maiolo [58]. In ogni caso, però, entrambe le versioni tramandateci non trovano la benché minima conferma nei documenti ufficiali.
L’ipotesi di una fondazione monastica sotto gli Ottoni è assurda e subito smentita dall’esistenza dei diplomi dei secoli VIII e IX che già fanno riferimento ad un “monasterium” [59].
Una seconda ipotesi è così formulabile: un Ottone, forse Ottone II, forse con l’aiuto di s. Maiolo, avrebbe apportato modifiche ed ampliamenti alla chiesa e/o al cenobio. A sfavore però dell’identificazione dell’imperatore in questione con Ottone II cito un’altra testimonianza, tramandataci da un Registrum investiturarum proveniente dall’archivio di S. Felice, che regesta numerosi atti del monastero a partire dal 1490 [60]. Sulla carta 18r del codice, una mano verosimilmente attribuibile alla prima metà del secolo XVI annota ancora una volta l’elenco di corpi santi conservati nel monastero: tale elenco è molto simile, ma non identico, a quello testimoniato dalla lapide di cui sopra. Anche in questo caso si cita l’intervento costruttivo di s. Maiolo e di Ottone II, tuttavia vi è una novità: un brano completamente inedito, che non compare né nel Catalogo Rodobaldino, né nell’iscrizione muraria, né altrove. Il terzo capoverso del testo recita infatti: “… et per ipsum prelibatum dominum imperatorem ipsum monasterium datum fuit ut patet per publica privilegia sita in ipso monasterio penes venerabilem ac honestissimam religiosam dominam Ursinam de Hera abbatissam ipsius monasterii…”. Dal momento che Ursina fu badessa di S. Felice nella prima metà del secolo XV, la fonte da cui vennero copiate le informazioni del Registrum, e pertanto anche quelle della lapide, era probabilmente uno scritto coevo al suo abbaziato, conservato nell’archivio del monastero. Ma ciò che più interessa rilevare è che l’edificazione di Ottone II è posta in stretta correlazione a fantomatici privilegi che sarebbero stati concessi dallo stesso imperatore e conservati nel monastero ancora nel secolo XV: ora, non si può escludere che tali privilegi esistessero e risultassero dispersi già all’epoca del Muratori, il quale, accostatosi all’archivio di S. Felice prima della diaspora, non li cita nella sua opera; tuttavia è più plausibile supporre che, essendo probabilmente stati custoditi insieme ad altre carte antiche, puntualmente pervenuteci, il motivo del loro mancato reperimento risieda nella loro effettiva inesistenza. Mi sembra più ragionevole supporre che i privilegi cui si allude nel testo siano quelli ben noti di Ottone III (in cui, come vedremo, si parla anche di Ottone II), malamente travisati.
La situazione, già abbastanza intricata, venne ulteriormente confusa dai tentativi di corroborare il presunto interessamento di Ottone II per il monastero intrapresi da autori di epoca medievale e moderna. Il Maiocchi [61], per esempio, cita quale prova di questa straordinaria affezione di Ottone II il fatto che l’imperatore avrebbe donato al cenobio una porzione del legno della santa croce, tuttora conservata in S. Michele [62]. L’affermazione si basa su una frase (l’unica in cui i documenti ufficiali di S. Felice citino Ottone II) del diploma concesso a S. Felice da Ottone III nel 1001 [63]: “…monasterio in quo habetur preciosum lignum sanctae crucis quod temporibus gloriosi atque victoriosi imperatoris Ottonis a bone memorie Benedicto episcopo eterne urbis Hierosolimis inventum est”, da cui in realtà non è affatto possibile desumere che il legno della croce venisse donato al monastero da Ottone II, bensì solamente che fu reperito da papa Benedetto VII quando Ottone II era imperatore e successivamente elargito da qualcuno a S. Felice. Dunque l’unica testimonianza storicamente significativa relativa ad Ottone II non prova assolutamente che questi si interessasse al cenobio nel corso della sua breve vita.
Un secondo tentativo tutto pavese di collegare la figura di Ottone II al monastero consiste nell’elaborazione della leggenda di Felicita, presunta figlia dell’imperatore, che avrebbe preso il velo nel monastero di S. Felice e, dopo aver condotto una vita di esemplare santità, vi sarebbe stata tumulata insieme alle spoglie di s. Giorgio martire [64]. La tradizione è già attestata dalla più antica fonte in nostro possesso, il citato Catalogo Rodobaldino: “Item subtus altare maius iacet corpus sancte Felicitatis filie regis Ottonis que eundo ad maritum intravit dictum monasterium et ibi vitam finivit” [65], che tuttavia non specifica ancora di quale Ottone fosse figlia la fanciulla. Perpetuatasi per tutto il medioevo [66], con la lapide del XV secolo la leggenda assume connotati definitivi, individuando nel padre di Felicita il secondo Ottone [67]: tali connotati verranno riproposti dagli storici dei secoli successivi con progressivi abbellimenti – per cui si passeranno in minuziosa rassegna le virtù della santa, e si ricorderà la sua caparbia opposizione ai voleri del padre che l’avrebbe voluta maritare: particolare questo che, riferito da Gualla e Ghisoni, appare indubbiamente ridicolo se si pensa che alla morte di Ottone II la sua primogenita aveva cinque anni [68]. Così, attraverso una lunga serie di rielaborazioni ed ampliamenti, la tradizione, ormai consolidata, si perpetuerà sino ai nostri giorni. Ma proprio questa tradizione, se esaminata alla luce dei documenti, si rivela inconsistente. Innanzitutto, dai regesti del Böhmer apprendiamo che nessuna delle due figlie di Ottone II si chiamava Felicita: alla maggiore era stato dato il nome di Adelaide, in omaggio alla nonna paterna, ed alla secondogenita quello di Sofia, di ascendenze bizantine [69]. Sempre attraverso i regesti possiamo seguire le vicende salienti della vita delle due principesse [70]: Adelaide è consacrata monaca nel monastero di Quedlinburg nell’anno 995, Sofia già nel 989, a soli undici anni, in quello di Gandersheim; entrambe diverranno a suo tempo badesse dei rispettivi cenobi. È perciò evidente che nessun tipo di rapporto lega alcuna delle due principesse al monastero di S. Felice. Il discorso è valido anche se consideriamo l’eventualità che Felicita fosse figlia non di Ottone II ma di Ottone I: questi ebbe infatti una figlia di nome Matilde, anch’essa badessa di Quedlinburg prima di Adelaide [71]. Ottone III, come è noto, non ebbe figli.
Dunque, alla luce dell’indagine storica, la tradizione che identifica Felicita con la figlia di un Ottone va annoverata nel numero di quelle leggende medievali finalizzate ad accrescere il prestigio delle istituzioni cui si riferiscono.
D’altro canto non si può negare che spesso tali leggende, per quanto inverosimili, traggono il loro fondamento da eventi storici: considerando che sin dall’inizio della sua storia S. Felice venne concesso ad esponenti femminili delle famiglie regnanti, si può forse supporre l’esistenza nel monastero, in data imprecisata, di una congiunta degli Ottoni, che avrebbe originato la tradizione. Tutavia ciò che mi interessa maggiormente sottolineare è il fatto che il nucleo fondamentale della leggenda, utilizzato da secoli come elemento probante dei legami fra Ottone II ed il monastero, rivela qui tutta la sua inconsistenza.
Non confutabile, ma privo di fondamenti storici, risulta anche, a questo punto, il corollario di tradizioni collegate alle vicende di Felicita ed alle presunte donazioni ottoniane, fra cui spicca quella delle reliquie di s. Giorgio [72], le quali, provenienti dall’Oriente, sarebbero state portate in dote da Teofano al marito e da questi donate a S. Felice, vuoi a suggello della pace fatta con la madre Adelaide, vuoi per onorare il cenobio prescelto dalla figlia. L’unica data certa relativa a queste reliquie è il 1014 [73], anno in cui esse erano indubbiamente presenti nel cenobio.
A conclusione di questa rapida carrellata su miti e leggende del S. Felice, non solo risulta evidente che i rapporti di Ottone II (e di s. Maiolo) con il cenobio non ricevono conferma alcuna in ambito documentario, ma contro l’esistenza di tali rapporti si profila un’altra argomentazione di non poco rilievo. Non va infatti dimenticato che proprio s. Maiolo, insieme all’imperatrice Adelaide, ristrutturò e diede nuove regole al monastero di S. Salvatore fuori le mura, cui lo stesso Ottone II concesse un diploma [74]; tale monastero non solo esibiva un’intitolazione identica all’originaria di S. Felice, ma, coincidenza insolita, conservava anche fra le sue reliquie un “corpus sancti Felicis” [75], menzionato esplicitamente in tre donazioni, sospette di falsità, elargite da Adelaide al cenobio nel 999 [76]. Sembra pertanto probabile che l’identità dei nomi dei due enti e la presenza in essi delle reliquie di due santi anch’essi omonimi abbiano contribuito ad ingenerare confusione e false attribuzioni: i fondatori e riformatori di S. Salvatore fuori le mura, nel gran calderone della tradizione comune, che rimescola i nomi e sbiadisce i connotati, sarebbero ben presto diventati anche fondatori e riformatori del secondo S. Salvatore, detto anche S. Felice.
L’ipotesi che si può formulare a questo punto, alla luce delle attuali, limitate conoscenze, è molto più vaga di quelle da cui eravamo inizialmente partiti: l’ampliamento della chiesa ipotizzato dalla storia dell’arte potrebbe essersi verificato in una non meglio precisata epoca ottoniana; forse in seguito a tali vicende, o all’arrivo di nuove reliquie, accanto all’antica intitolazione al Salvatore si sarebbe aggiunta quella a s. Felice. Ritengo anche che la leggenda di un’ottoniana fondazione ex novo del monastero sia nata dal fatto che sotto Ottone III vennero tenuti i più antichi placiti [77] e concessi i più antichi diplomi [78] conservati nel tabularium del cenobio. Tale generica leggenda, esistente già nel secolo XIII ed attestata dal Catalogo Rodobaldino, a partire almeno dal secolo XV definì i suoi connotati eleggendo come protagonisti Ottone II e s. Maiolo, a causa sia della confusione con l’omonimo S. Salvatore fuori le mura, sia di una errata interpretazione dei documenti.
Ricollegandoci, dopo questa ampia digressione, alle vicende storiche individuabili attraverso placiti e diplomi, con il 1001 si apre per il monastero un’epoca di donazioni imperiali, inaugurata da una falsa concessione di Ottone III [79] mediante la quale S. Felice si appropria di un consistente nucleo di beni situati nel milanese, nel bergamasco, nel pavese, nell’alessandrino e sul Lago Maggiore. Successivamente altre donazioni [80] sottoporranno al cenobio anche le curtes di Spinetta Marengo, Corviglia e Castellazzo Bormida, nonché numerosi possedimenti in Piemonte e presso Piacenza. Pertanto nella prima metà del secolo XI si verifica un innegabile consolidamento del patrimonio e del prestigio di S. Felice: le ricchezze gestite dal monastero sembrano assicurargli un posto di primo piano fra gli enti ecclesiastici pavesi. Questo periodo di splendore è però effimero e destinato a lasciar posto ad una realtà molto più “ordinaria”. Alla serie di concessioni imperiali segue un silenzio delle carte che dura quasi un secolo; successivamente, i più antichi documenti privati pervenutici, risalenti agli anni ’20 del secolo XII [81], disegnano una nuova geografia dei possedimenti assolutamente irrisoria rispetto alla precedente: scomparse le grandi proprietà in Lombardia, Emilia e Piemonte, spettano ormai al monastero solamente terreni, edifici e cappelle in Pavia e nel pavese [82]. La possibilità di recitare un importante ruolo sulla scena politica ed economica locale è sfumata, e per tutto il medioevo S. Felice si manterrà in posizione secondaria, seppur non insignificante, rispetto alle grandi istituzioni monastiche quali S. Pietro in Ciel d’Oro, S. Maria Teodote, S. Salvatore. Le ragioni del drastico ridimensionamento possono forse essere ricercate nell’assegnazione dell’ente con facoltà di nominarvi la badessa, nonché di tutte le sue pertinenze, al vescovo di Novara, come leggiamo in un diploma del 1025 elargito da Corrado II alla chiesa di Novara [83]. Nel 1028 l’imperatore ribadirà la medesima concessione [84]. Con un placito del 1043 aprile 19, tenuto in Pavia da Adalgerio cancelliere e messo di Enrico III [85], il monastero si libererà momentaneamente della soggezione, rendendosi nuovamente indipendente, ma nel 1060 la subordinazione verrà ribadita da Enrico IV [86]. I motivi sottesi alla dipendenza novarese ci sfuggono. Benché il Cognasso supponga che i beni menzionati nel diploma del 1025 e nei successivi facessero capo a seguaci di Arduino, spogliati definitivamente dall’imperatore a vantaggio di Pietro III vescovo di Novara [87], non è possibile generalizzare. Pertanto non ci è dato di sapere perché S. Felice fosse incluso in tale elenco di beni, considerando anche che l’ultimo diploma, del 1014, lo mostrava oggetto del favore imperiale.
Il Ghisoni immagina che dopo il 1060 Enrico IV, per non venir meno alle disposizioni paterne, avesse esentato il monastero dalla giurisdizione della chiesa novarese [88], ma in realtà non possediamo alcun documento che ponga termine alla dipendenza [89]. Il “buco” archivistico si protrae per circa ottant’anni: il più antico documento privato pervenutoci, del 1122 [90], ed i successivi, non accennano comunque ad alcuna relazione con il vescovo di Novara. Un’ulteriore attestazione della cessata dipendenza dalla chiesa novarese è contenuta nella Charta Consuetudinum Antiquarum Ticinensis Ecclesiae [91], databile dopo la prima metà del secolo XII, dove si enunciano gli impegni che S. Felice dovrà sostenere ed i tributi che dovrà pagare alla Cattedrale di Pavia in occasione della festa del suo martire. È invece del 1206 il primo privilegio, concesso da Innocenzo III a Bernardo vescovo di Pavia [92], che annovera nell’elenco degli enti sottoposti al vescovo anche il “monasterium Sancti Felicis cum capella et parochiis suis”. Nel documento si citano quattro privilegi elargiti alla chiesa pavese dai predecessori di Innocenzo: di questi i due più antichi, concessi da Callisto II [93] e da Innocenzo II [94] non menzionano il monastero. La coppia di privilegi successivi, l’uno elargito da Eugenio III e l’altro da Anastasio V, non è pervenuta.
2. La storiografia
Il materiale storiografico relativo a S. Felice non è abbondante e, soprattutto, eccezion fatta per qualche osservazione sporadica del Muratori e del Mabillon [95], non varca i confini municipali. La scarsa rilevanza dell’ente sul piano economico-politico fece sì che solamente gli storici locali si interessassero alle sue vicende, mentre ricercatori di fama nazionale ed internazionale appuntavano il loro interesse su istituzioni più rappresentative.
La storiografia pavese dei secoli più remoti è caratterizzata dall’assenza di cronache cittadine e di opere storiche a carattere “laico”: la produzione locale, fondamentalmente di natura religiosa ed ecclesiastica, trae alimento dal glorioso passato che aveva arricchito la città di reliquie e di chiese per lo più fondate da sovrani longobardi [96]. Ne consegue che, nelle testimonianze di epoca medievale e di buona parte dell’età moderna, il fulcro essenziale della narrazione è costituito per un verso dall’esaltazione degli edifici religiosi con i corpi santi ivi custoditi, per l’altro dalle biografie di re longobardi, di santi e vescovi locali che spesso di quelle chiese furono i fondatori.
Un altro elemento saliente della storiografia più antica, che ho potuto ben constatare durante la ricerca di notizie specifiche su S. Felice, è la sua ripetitività: ogni autore preferisce riecheggiare ed ampliare (concedendo largo spazio all’immaginazione personale) quanto già letto nelle opere dei suoi predecessori, piuttosto che svolgere una ricerca autonoma su fonti attendibili. Di qui il ripetersi per secoli e secoli di stereotipi privi di fondamento. Per assistere allo sviluppo embrionale di una mentalità storica bisogna aspettare gli albori del secolo XVIII. Alle caratteristiche sopra enunciate si conforma perciò anche la natura delle informazioni che possediamo su S. Felice, riguardanti soprattutto la fondazione del monastero e le reliquie ivi conservate: sono notizie che, affermate dalle fonti più antiche nel secolo XIII, si ritrovano identiche ed ampliate nel XVII, senza che mai compaia l’ombra di una citazione documentaria. Tale prassi, peraltro riscontrabile in molte altre città, costituisce un vero e proprio handicap per la ricerca storica odierna: il fatto che una notizia sia citata da autori del XIII, XIV, XV, XVI secolo, sembra deporre immediatamente a favore della sua veridicità, mentre in realtà molto spesso l’unica fonte da prendere in considerazione è la più antica, di cui le altre costituiscono solamente un’eco. Solo con la storiografia dei secoli successivi si avrà una svolta e verranno avanzate nuove ipotesi sulla base di documentazione attendibile.
Le notizie più antiche sul monastero sono quelle contenute nel Catalogo Rodobaldino [97]. È questo un elenco di corpi santi attribuito al vescovo Rodobaldo II e risalente all’anno 1236: di ogni chiesa pavese sono indicate le reliquie, per un totale di 141 corpi. Del Catalogo ci sono pervenute numerose copie, più o meno corrette e rimaneggiate da mani successive. Quella di cui Boni e Maiocchi danno l’edizione è del primo quarto del secolo XV [98]. Le reliquie conservate in S. Felice sono piuttosto numerose, e fra di esse spiccano: il legno della s. Croce, il corpo della martire s. Marina “que … vixit inter monachos tamquam monachus”, il corpo di s. Felice che diede il nome alla chiesa, quello di s. Giorgio e quello della famosa santa Felicita.
La seconda fonte, in ordine di tempo, è il noto Liber di Opicino de Canistris, del quale già molti studiosi hanno fornito dettagliate analisi [99]. Scritto ad Avignone nel 1330, il Liber descrive Pavia con particolare riguardo per le sue chiese ed i suoi corpi santi, nel tentativo di evidenziare la sacralità e religiosità della patria dell’autore [100]. Secondo il Gianani, Opicino per la stesura della sua opera non si servì né del Catalogo Rodobaldino né di altre fonti precedenti, tuttavia indubbiamente doveva averne presenti i contenuti che facevano parte “delle credenze e conoscenze dei divoti fedeli d’allora” [101]. Anche in quest’opera la “ecclesia S. Felicis episcopi et martiris” ci è presentata mediante una panoramica sulle sue reliquie [102], che comprende quelle di Felice, Sergio e Bacco, Castulo e Marina e “alie reliquie plures”, ma omette s. Giorgio e s. Felicita [103].
Di circa centocinquant’anni successive sono le Historiae suae patriae del Gualla, in sei libri, edite nel 1505 dopo la morte dell’autore [104]. Il Capsoni, nell’introduzione al secondo libro delle sue Memorie [105], annovera il Gualla nel numero degli “annalisti puerili senza criterio, troppo inclinati al magnifico ed alla credulità”, e definisce la sua opera “informe ammasso”. Tale giudizio, sebbene forse un po’ troppo duro, è però indicativo dello spirito che permea il lavoro dello studioso: le biografie di vescovi e di santi, le cui reliquie erano venerate nelle chiese di Pavia, si mescolano a quelle dei re longobardi che fondarono le chiese, in un’accozzaglia di nozioni prive spesso del più elementare senso storico. Così, nel caso di S. Felice [106], l’autore accoglie due leggende antitetiche riguardanti la fondazione della chiesa (una ne attribuisce l’edificazione a s. Felice vescovo di Spalato, l’altra ad Ottone II) e le elenca l’una dopo l’altra senza scomporsi e senza fornire spiegazioni in merito [107]. Naturalmente è riportato ancora una volta il consueto elenco delle reliquie, con lunghe biografie dei santi più significativi.
Successivamente chi si occuperà ancora del S. Felice, ripercorrendone la fondazione, attribuita questa volta a san Maiolo (sulla base probabilmente dell’epigrafe già menzionata), e riproponendone ulteriormente l’elenco delle reliquie, sarà “un povero ma venerando bidello” [108] dell’Accademia Pavese degli Affidati: Stefano Breventano. Cercando di coniugare, come già aveva fatto il Gualla, l’esaltazione religiosa della patria con l’ammirazione per le gesta dei re longobardi, il Breventano allinea nei primi tre libri biografie di vescovi e di pii sovrani ricordati insieme alle loro fondazioni. Il quarto ed ultimo libro è dedicato ad “altri edificatori di chiese in Pavia”: qui il discorso può cadere su S. Felice e sul suo presunto fondatore Maiolo. Nella descrizione dei corpi santi il Breventano sembra però aver attinto a fonti diverse dal Gualla: lo desumiamo per esempio dal particolare, sinora inedito nella tradizione pavese, del martirio di s. Felice avvenuto sotto Diocleziano (il Gualla parla invece di un “Tarquino imperante”, mentre il Ghisoni successivamente farà riferimento a Decio).
Anche il Bossi, giurista ed erudito pavese nato nel 1588, nella sua vasta produzione ebbe modo di sviluppare argomenti relativi al monastero ed al santo suo presunto fondatore. I suoi manoscritti, frutto di un’instancabile attività di ricerca e compilazione, “vennero formando il patrimonio documetario cui poi attinsero scrittori e storici ottocenteschi di cose ticinesi” [109], benché il Capsoni osservi che “la disgrazia fu che in quegli zibaldoni ei stava raccogliendo ancora, non meditando; né sopravvisse ad una tal fatica quant’era necessario per trascegliere il buono ed ordinarlo” [110]. Ancora una volta il giudizio del Capsoni sembra colpire nel segno: infatti fu il Bossi che per primo annoverò erroneamente s. Felice nella lista dei più antichi vescovi di Pavia, sostenendo che il santo avrebbe ricevuto il martirio a Spalato, sotto Decio, nel 255, e sarebbe stato tumulato “in altri secoli … nel tempio che li dedicò Oton imperatore a persuasion di s. Maiolo abate” [111]. Pertanto la vicenda originaria già poco chiara di per sé venne complicata notevolmente dalla confusione di un s. Felice spalatense con un s. Felice pavese. Merito del Bossi fu invece quello di aver trascritto la lapide murata in una parete della chiesa ed elencante i corpi santi ivi custoditi, diffondendone la conoscenza fra gli scrittori successivi [112].
Il Mabillon [113] si occupò di S. Felice solo marginalmente, citando nei suoi Annales dedicati all’ordine benedettino i diplomi di Ludovico II [114] e di Arnolfo [115], in cui il monastero della Regina è menzionato unitamente al più importante S. Salvatore di Brescia. In particolare, rifacendosi alla concessione di Arnolfo, ove sono elencati anche i cenobi pavesi di S. Marino e S. Tommaso, lo studioso afferma che “in unum ex his monasteriis, forte Reginae” sarebbe stata accolta la regina Ethelswith di Mercia [116]; tuttavia non si sa in base a quali dati il Mabillon avanzi tale supposizione, che pertanto non può essere né corroborata né criticata.
È del 1699 un’opera pavese che si pone idealmente sulla scia delle precedenti: la Flavia Papia Sacra di padre Romualdo Ghisoni. Si tratta di quattro libri dalla classica impostazione: nei primi tre l’autore si sofferma sulle vicende dei santi sepolti in Pavia e delle loro reliquie, nel quarto delinea ancora una volta le vicende dei re longobardi. Anche nei suoi confronti il giudizio del Capsoni non è del tutto benevolo [117]: “… sarebbe l’autore più benemerito se in tanta sua diligenza e fatica men si lasciasse trasportare da un eccessivo e mal inteso amor della patria”. Il Ghisoni, che afferma di attenersi preferibilmente al Bossi, ritenendolo lo storico più accurato, non disdegna di riproporre informazioni desunte da Gualla, Breventano, Spelta, Sacco, Opicino de Canistris (indicato con il nome di Sigibertus), Parata e Berretta [118]. L’opera risente dell’impianto tradizionale ormai obsoleto e presenta i ben noti limiti: luoghi comuni, ripresa delle solite leggende, nonché errori clamorosi fra cui spicca la collocazione del monastero presso la porta Palacense, dunque nella zona orientale della città anzichè in quella occidentale. Tuttavia non possiamo disconoscere al Ghisoni l’impegno chiarificatore che lo spinge a rivedere le contraddittorie informazioni tramandate dal Gualla sulla fondazione del cenobio, differenziando le azioni di un s. Felice “vescovo di Pavia” (e qui cade malamente confidando troppo nel Bossi) costruttore, da quelle di Ottone II che ne sarebbe stato esclusivamente ristrutturatore. Ma ciò che soprattutto distingue l’opera del Ghisoni da quella degli autori precedenti è la presenza in embrione di una nuova mentalità storicistica: per la prima volta lo studioso menziona, seppure sporadicamente, diplomi imperiali e formula congetture in base ai loro contenuti. Così, per esempio, il Ghisoni è il primo a sostenere l’antichità del monastero sulla falsariga del privilegio di Arnolfo dell’889 [119]. Si tratta di tentativi di indagine scientifica ancora marginali, quasi sperduti nel mare magnum delle citazioni ripetitive, eppure indicativi di un nuovo spirito di ricerca che si affermerà nel secolo successivo.
Nel corso del secolo XVIII sarà uno studioso di fama nazionale ad occuparsi delle vicende del monastero: il Muratori, infatti, pubblica nelle sue Antiquitates Italicae [120] e nelle Antichità Estensi [121] le più antiche carte rinvenute nell’archivio di S. Felice, fornendo in tal modo ai suoi contemporanei e successori gli indispensabili strumenti per lo sviluppo di una storiografia veritiera e scientificamente fondata. Lo studioso inoltre [122] si soffermerà sull’analisi dell’appellativo “Regine” e, con l’ausilio del diploma d’Arnolfo dell’889, dimostrerà la sua antichità.
Grande utilizzatore delle preziose fonti pubblicate dal Muratori sarà il Robolini, valoroso storico pavese che nella vasta opera pubblicata tra il 1823 ed il 1838 e dedicata alla sua città si mostra poco incline ad indulgere verso fantasiose tradizioni, e rompe una volta per tutte con la consueta, esclusiva esaltazione dei santi e dei re longobardi. Piuttosto, le Notizie del Robolini consistono in una descrizione degli eventi occorsi alla sua patria dalle origini sino al 1512, disposti in ordine cronologico e successivamente ampliati con note, aggiunte, correzioni. In questa struttura piuttosto asimmetrica risiede il maggior difetto dell’opera, che rappresenta però nella sua globalità un progresso notevolissimo rispetto al passato. Il Robolini ricostruisce per primo le antiche vicende del S. Felice [123] sin dalla sua fondazione longobarda, identificando felicemente l’antico monastero del Salvatore e quello della Regina con quello di S. Felice. Una volta appurata l’antichità dell’istituzione, il Robolini ipotizza che l’appellativo “Regine” sia da attribuire ad Ansa, cofondatrice dell’ente, e smentisce le teorie, testardamente sostenute per secoli, relative alle fondazioni di s. Felice ed Ottone II.
Utilizzò ampiamente le indicazioni del Robolini il sacerdote Rodolfo Maiocchi [124], appassionato studioso delle cose di Pavia nonché rettore del Collegio Borromeo, che nel 1903 diede alle stampe un’operetta riguardante le chiese pavesi elencate in ordine alfabetico (purtroppo interrotto alla lettera G). La monografia che il Maiocchi dedica a S. Felice costituisce a tutt’oggi la fonte cui maggiormente hanno attinto gli storici che a diverso titolo si sono occupati dell’istituzione, poiché presenta un esauriente rendiconto del materiale raccolto nei secoli passati, vagliato però con discernimento di roboliniana memoria. Nonostante i limiti che un’opera siffatta presenta, limiti imputabili essenzialmente al fatto che ormai in alcune sue parti risulta datata ed un poco ingenua, il contributo del Maiocchi resta comunque utilissimo per l’abbondanza delle informazioni che esauriscono praticamente tutte le vicende note del S. Felice, dalle origini sino alla sua soppressione.
Nonostante la progressiva specializzazione ed atomizzazione delle ricerche storiche ed artistiche, il nostro secolo non ha ancora visto la pubblicazione di uno studio monografico sul monastero: l’istituzione è stata citata qua e là nei lavori di coloro che a diverso titolo si sono occupati di Pavia, ma le specifiche tematiche non sono state approfondite al fine di colmare le numerose lacune che sussistono tuttora [125].
3. I possedimenti
Ben poco si sa dei beni posseduti da S. Felice prima del XII secolo: per informazioni circa la localizzazione, l’estensione e le caratteristiche di tali beni rinvio comunque al paragrafo 1.3 di questa introduzione, e soprattutto alle note esplicative preposte ai docc. nn. 1 e 6.
Più agevole è la ricostruzione delle vicende storico-economiche del cenobio nei secoli XII-XIV, poiché aumenta considerevolmente il numero di carte provenienti dal suo archivio e pervenute sino ai nostri giorni.
È una storia, quella di S. Felice, priva di grandi avvenimenti (se si fa eccezione per il “fosco dramma svoltosi nel monastero verso il 1378” quando, ci informa il Maiocchi, la monaca Caterina venne riconosciuta colpevole di aver avvelenato la consorella Caracossina) [126], scandita essenzialmente da atti relativi alla gestione di un non trascurabile patrimonio immobiliare, dal regolare succedersi delle badesse, talvolta dal sorgere di controversie con privati o con altri enti, in particolare con S. Maria Teodote [127].
Nella prima metà del secolo XII i beni del cenobio risultano essenzialmente costituiti da appezzamenti di terra siti in Costa Caroliana, nel Siccomario [128]. Fra queste proprietà spicca la chiesa di S. Felice de Caluliano, dipendente dal monastero, che è menzionata per la prima volta in una carta del 1142 [129], ma dovrebbe essere stata fondata e dotata di beni dal monastero stesso approssimativamente attorno al primo quarto del secolo XII [130]. La chiesa era retta da un sacerdote nominato dalla badessa e confermato dal vescovo, e possedeva terre proprie [131]. Attualmente non esiste più, essendo stata probabilmente distrutta da una delle piene del Ticino [132].
Nella prima metà del XII secolo è documentata la formazione di un secondo importante nucleo di beni, ubicati in Pieve Porto Morone, Badia Pavese, Muçana e nei loro territori [133]. Il primo atto riguardante questa zona è un munimen del 1148, con il quale Pagano de Cellanova acquista quarantotto iugeri di terra dai coniugi de Riale [134]; successivamente, nel 1181 [135] il monastero riceve un lascito di beni immobili e mobili situati “infra hoc Ytalicum Regnum”: ne desumiamo la collocazione nei pressi di Pieve Porto Morone grazie ad un’annotazione apposta sul verso della carta [136]. Nel 1206 [137] una carta venditionis attesta l’acquisto da parte del monastero di un podere di più di otto mansi nei territori in questione. I venditori sono membri della già menzionata famiglia de Cellanova, che, pur possedendo altri terreni nelle stesse località [138], risultano pesantemente indebitati, in particolare nei confronti dei de Beccaria [139] e per questo motivo costretti a vendere. In seguito S. Felice confermerà ed amplierà la sua presenza nel territorio mediante investiture [140] e permute [141], effettuate sia con l’abbazia di S. Cristina di Olona [142] che con privati, fra i quali spicca la famiglia dei conti de Rovescalla [143]. Da una stima del 1353 [144] apprendiamo che il monastero possedeva nei territori di Pieve Porto Morone e Badia Pavese duecentotrentacinque biolche e centoquarantatrè pertiche.
Un terzo, significativo nucleo di beni è quello facente capo alle cascine di Melone (comune di Casarile) e Cavagnate (comune di Rognano), situate lontano dal Naviglio Pavese, fra Pavia e Milano. Anche Meronum, come il precedente Calulianum, compare già nell’elenco di beni concessi da Enrico II [145]; tuttavia, probabilmente a causa delle perdite subite dall’archivio monastico [146], i documenti che attestano possedimenti in questo territorio sono tardi: uno, datato “in loco Meroni”, risale al 1318 [147], un altro, in cui si parla espressamente di terre monastiche “que sunt in territorio Melloni”, è del 1338 [148]. Più antiche sono le carte private relative a cascina Cavagnate: un regesto del 1689 ci riconduce al 1166 [149], mentre il primo documento effettivo è una carta consignationis del 1223 [150]. Da una stima effettuata nel 1353 [151] ricaviamo che i beni di S. Felice nei territori delle due cascine ammontavano a più di sei mansi di terra e comprendevano “domos, caxamenta, sedimina, vineas, terras, pratas, boscha, padula, proprietates et res”.
Di capitale importanza per l’economia del cenobio dovevano essere anche i beni posseduti in Pavia, principalmente case e terreni, ubicati per la maggior parte in porta Marenga: talvolta nello stesso castellarium dell’ente [152], o presso la pusterla del cenobio che si apriva nelle mura della città [153]; talvolta più genericamente collocati nella parrocchia di S. Felice, o vicino ad altre chiese. Buona parte delle carte qui edite riguarda investiture o vendite di case e terreni effettuate dal monastero a beneficio di privati: è difficile censire l’entità precisa di tale ricchezza immobiliare, perché risulta disagevole identificare i medesimi beni nell’arco di tre secoli, tuttavia i dati che emergono dalla lettura delle carte in questo lasso di tempo lasciano supporre l’esistenza di un patrimonio costituito da oltre trenta case e da altrettanti terreni.
Fra i possedimenti in Pavia non vanno poi dimenticati i mulini ad acqua che sorgevano lungo la Carona occidentale, spesso causa delle sopraccitate controversie con S. Maria Teodote che a sua volta possedeva consimili edifici presso la roggia. L’esistenza di un molendinum del monastero è già affermata da un documento del 1182 [154]; in seguito apprendiamo che i mulini erano due [155], e che almeno uno di essi, nel secolo XIV, aveva annessa una casa “murata e cuppata” ed era provvisto di due ruote e due paia di mole [156].
Da non dimenticare, infine, l’esistenza di un’ulteriore cappella dipendente da S. Felice, la già citata “ecclesia S. Petri de S. Felice”: attestata dalle carte solo sino al 1256, è però ancora citata da Opicino nella prima metà del XIV secolo [157].
4. L’archivio
4.1. Le pergamene
In seguito alla soppressione degli enti religiosi non dediti ad insegnamento, verificatasi in area lombarda negli ultimi anni del secolo XVIII per volontà di Giuseppe II, le carte provenienti dagli archivi di tali enti subirono una rovinosa diaspora. Per questo motivo, prima di intraprendere l’edizione di un fondo documentario monastico è necessario un lavoro di ricostruzione preliminare che consenta di individuare e raggruppare documenti ormai dispersi in diversi archivi e biblioteche.
La ricomposizione dell’archivio medievale di S. Felice ha costituito la premessa necessaria al lavoro di edizione. Analoghe ricostruzioni archivistiche in area lombarda, alcune già edite, altre in corso di pubblicazione, aventi come oggetto le carte dei monasteri pavesi di S. Pietro in Ciel d’Oro [158] e di S. Maria de Ortis [159], nonché quelle di S. Maria di Morimondo [160] e di S. Giulia di Brescia [161], mi hanno fornito indicazioni metodologiche utili ai fini della ricerca e catalogazione delle pergamene.
Purtroppo il materiale membranaceo anticamente custodito nell’archivio del monastero e giunto sino ai nostri giorni è esiguo: di tutte le pergamene prodotte nel lasso di tempo, di circa quattro secoli, intercorrente fra il 998 gennaio 15 (data della pergamena più antica conservata nell’archivo di S. Felice), ed il 1400 maggio 22, mi è stato possibile recuperarne solamente centocinquantacinque [162]. Tale esiguità raggiunge livelli assoluti in alcuni periodi: il “buco” archivistico di maggiori dimensioni si estende fra il 1043 ed il 1122, privandoci di notizie preziosissime relative alla storia antica del monastero ed alla fondazione della chiesa di S. Felice de Caluliano, ma anche per il periodo immediatamente successivo il materiale scarseggia: basti pensare che ci sono pervenute solamente trentotto carte vergate nel XII secolo.
Perdite tanto gravi sono imputabili in parte agli incendi cui il monastero di S. Felice, come gli altri edifici della Pavia medievale, andò indubbiamente soggetto [163] (un incendio notturno che bruciò l’archivio dell’ente è attestato dal Ghisoni, il quale tuttavia non ne segnala la data) [164], ed in parte alla menzionata diaspora avvenuta alla fine del XVIII secolo. Dopo la soppressione, il fondo documentario di S. Felice, così come quelli di molte altre istituzioni ecclesiastiche pavesi, confluì in massima parte, ma non esclusivamente, all’Archivio di Stato di Milano (ASMi) [165], allora avente sede in S. Fedele [166] e fu inizialmente collocato nel Fondo di Religione (FR), magistratura istituita nel 1787 [167] appositamente per ospitare gli archivi degli enti religiosi soppressi. In periodo napoleonico, per opera di Luigi Bossi e di Michele Daverio, che si ispiravano alla dottrina archivistica lombarda di matrice cisterciense-santambrosiana [168], le pergamene conservate nel Fondo di Religione vennero separate dal materiale cartaceo e riposte nella sezione denominata Archivio Diplomatico [169]; tuttavia, tale lavoro non venne attuato completamente, e, per questo motivo, numerosi pezzi mantengono tuttora la loro collocazione nelle cartelle del Fondo di Religione. In conseguenza di tali spostamenti di materiale, le carte del S. Felice si trovano attualmente ripartite in due sezioni dell’Archivio Diplomatico (denominate rispettivamente Museo Diplomatico [170], ospitante le pergamene anteriori al 1100, e Pergamene per Fondi [171], comprendente il materiale membranaceo, suddiviso per fondi, posteriore al 1100), nonché nel già menzionato Fondo di Religione, parte antica [172].
Nel Museo Diplomatico è dunque custodito il materiale più antico proveniente dal cenobio pavese: il primo documento [173] in ordine di tempo è una carta privata, in copia coeva all’originale, del 998 gennaio 15: si tratta di un munimen in cui viene documentata la vendita di numerosi beni immobili dislocati in diverse zone dell’Italia settentrionale effettuata da Liutfredo, vescovo di Tortona, a favore di Ottone duca, probabilmente figlio di Corrado Conone marchese d’Ivrea [174]. Seguono altri sei documenti della prima metà del sec. XI: il primo [175] è un placito, cui presenziò Ottone III in Pavia il 1001 ottobre 14, nel quale il monastero viene riconosciuto “pars domni imperatoris seu istius regni”. Con due diplomi successivi [176], datati rispettivamente Ravenna 1001 novembre 21 e 1001 novembre 22 (il primo dei quali è un falso in forma di originale), Ottone III dona a S. Felice rispettivamente i beni menzionati nel doc. n. 1 e le corti di Spinetta Marengo, Corviglia e Castellazzo Bormida. Ritengo utile segnalare che questi due diplomi, conservati insieme ad un terzo non attinente a S. Felice, non vengono menzionati dal catalogo preposto alla consultazione del fondo, l’Indice generale delle pergamene (secc. VIII-XI) compilato da Luigi Osio [177], in quanto in tale elenco vengono riportati solamente la data ed il regesto del terzo diploma, datato Ravenna 1001 novembre 20 [178] ed attestante una concessione elargita da Ottone III alla pieve vogherese di S. Lorenzo. La mancata menzione è attribuibile probabilmente all’immissione posteriore dei due documenti nel fondo archivistico [179]. La serie delle carte prosegue con un placito, cui presenziò a Pavia il 1014 maggio 7 [180] l’imperatore Enrico II, che tutela i beni (di cui al doc. n. 1) del monastero contro le pretese dei fratelli Berengario ed Ugo, figli del conte Sigefredo, quindi con un diploma dello stesso Enrico II, datato Pavia 1014 [181], che conferma a S. Felice il possesso di tale patrimonio. Infine, l’ultima carta conservata nel Museo Diplomatico è un placito, tenuto a Pavia il 1043 aprile 19 [182] da Adalgerio, cancelliere e messo di Enrico III. Esistono altri documenti pubblici, oltre a quelli qui elencati, che menzionano S. Felice: si tratta di quelli cui ho fatto riferimento nel delineare le vicende storiche dell’ente. Essi non si trovano nel Museo Diplomatico perché estranei al tabularium del monastero pavese, ma sono così distribuiti: i tre più antichi [183], provenienti dall’archivio di S. Salvatore di Brescia, nella Biblioteca Queriniana di Brescia; i diplomi dati da Ludovico II e da Arnolfo ad Angelberga [184] nell’Archivio di Stato di Parma, in quanto provenienti dal monastero piacentino di S. Sisto fondato dall’imperatrice [185]; il diploma di Guido [186] nell’Archivio Capitolare di Parma. Le carte che invece sanciscono il passaggio di S. Felice sotto la giurisdizione del vescovo novarese sono conservate presso l’Archivio di Stato di Novara. Nessuno di questi documenti pubblici venne mai ospitato nel tabularium dell’ente pavese: a confermare ciò concorrono le motivazioni di ordine storico qui esposte, nonché l’assenza di mani “conosciute” (v. infra) sul verso delle pergamene. Esaminiamo ora la collocazione delle carte relative ai secoli XII-XIV. Uno spoglio sistematico del materiale ha fornito i seguenti risultati: la maggior parte delle pergamene è conservata nella sezione Pergamene per Fondi. Nella cartella n. 643 troviamo settantaquattro pezzi, nella cartella n. 644 sette: in entrambe inoltre sono presenti numerose membrane relative al monastero pavese di S. Maria in Monteoliveto [187]. Ulteriore materiale è stato individuato nelle cartelle n. 649 (due pergamene) [188]; nn. 698 (una pergamena), 699 (una pergamena) e 700 (una pergamena), incluse nel gruppo di cartelle denominato “Pavia Varia”, che annovera nel suo ambito i pezzi che gli archivisti, nel loro lavoro di riordinamento, non seppero attribuire con precisione ad alcun ente pavese.
Nel Fondo di Religione, parte antica, le cartelle assegnate a S. Felice vanno dalla n. 5978 alla n. 5991. In ciascuna di esse abbonda la messe di materiale cartaceo dei secoli XVI-XVIII, ma, come ho già segnalato, è dato di trovare anche pezzi membranacei (trentatrè in tutto, così distribuiti: quattro nella cart. 5978, uno nella cart. 5979, uno nella cart. 5981, diciassette nella cart. 5982, due nella cart. 5983, due nella cart. 5984, tre nella cart. 5985, due nella cart. 5987, uno nella cart. 5991), alcuni dei quali, sfuggiti all’attenzione degli archivisti, non sono neppure indicati negli inventari (è il caso della pergamena conservata nella cart. 5991).
Un secondo nucleo di pergamene provenienti da S. Felice si trova oggi nella Biblioteca Universitaria di Pavia: una porzione (dodici pezzi a tutto il XIV secolo) è conservata nel fondo Comi [189]; infatti inizialmente tutte le carte provenienti dagli archivi degli enti religiosi soppressi (circa tredicimila esemplari) confluirono in un salone presso S. Maria del Carmine dove furono riordinate dall’erudito pavese Siro Comi: successivamente, anche se la maggior parte di esse venne trasferita nell’ASMi, alcune rimasero in possesso dello studioso e, dopo la sua morte, in seguito a varie peripezie, nel 1851 vennero collocate presso la Biblioteca Universitaria [190]. Ulteriore materiale è distribuito nei fondi Aldini Carte Diverse (due pezzi) [191] e Robolini (dodici pezzi) [192], acquistati dalla Biblioteca rispettivamente nel 1840 e nel 1860 [193].
Infine, tre pergamene del XIV secolo [194], due delle quali recanti sul verso annotazioni di mano Comi che ne attestano la sicura provenienza pavese, sono conservate nella Biblioteca Ambrosiana: le ragioni di tale presenza ci sfuggono, ma vanno indubbiamente inquadrate nella politica di acquisti, lasciti e donazioni che caratterizza sempre la storia di una biblioteca.
Benché nella presente tesi di dottorato siano stati editi esclusivamente i pezzi conservati a Milano e Pavia, provenienti direttamente dal tabularium del monastero, è d’obbligo ricordare anche l’esistenza di ventiquattro documenti pervenutici in copia attraverso le pagine del Codex Astensis [195] relativi a beni posseduti da S. Felice in Villanova d’Asti. Qui, secondo quanto testimoniano le carte, rogate negli anni 1184-1215 [196], esisteva anche un secondo monastero di S. Felice, dipendente da quello pavese, la cui situazione economica, però, non era delle più floride. Già indebitato nei primi anni del secolo XIII, nel 1215 risultava talmente oberato da costringere il cenobio pavese a vendere per seicento lire tutti i beni di Villanova al comune di Asti. Le carte relative a tali beni, cedute insieme alle terre alienate, abbandonarono l’archivio monastico e, dopo essere state trascritte nel Codex Astensis, andarono probabilmente disperse. I rapporti tra S. Felice e Villanova d’Asti, però, non vennero completamente interrotti, dal momento che nel 1328 [197] fu accolto nel monastero come converso Manuel Drachonus de Villanova.
Indubbiamente in sede di edizione definitiva i documenti “astigiani” troveranno quella collocazione che non è stata loro fornita nella presente tesi, circoscritta ai fondi di Pavia e Milano.
Pur non escludendo la possibilità, seppur improbabile, di ulteriori recuperi di materiale in archivi minori, in virtù dello spoglio sistematico compiuto ritengo di aver raccolto ed elencato qui tutti i pezzi archivistici soppravvissuti alle distruzioni ed alla diaspora del tabularium di S. Felice.
4.2. I registri
Di regola il lavoro di ricomposizione di un fondo documentario viene condotto sulla falsariga di registri, compilati in occasione di riordinamenti archivistici avvenuti nei secoli XVII e XVIII [198] prima della dispersione delle pergamene o, in casi ancora più fortunati, nel medioevo [199]. Tali registri contengono l’elenco dei documenti appartenuti all’archivio, ordinati secondo un criterio che spesso è cronologico o tematico: ogni documento viene solitamente individuato tramite una segnatura, la data, ed un regesto più o meno particolareggiato. Spesso i dati così segnalati nei registri venivano apposti anche sul verso del documento corrispondente, in modo da renderne più agevole l’identificazione.
Nel caso di S. Felice, tuttavia, il recupero del materiale risulta notevolmente ostacolato dalla mancanza di un vero e proprio registro indicante il numero delle carte presenti nell’archivio prima del suo smembramento.
Da un esame svolto sulle annotazioni apposte sul verso delle pergamene è possibile desumere che in età medievale un riordinamento sistematico dell’archivio non ebbe luogo. Le mani che compaiono con una certa frequenza sono infatti esclusivamente: quella del notaio scrittore, o talvolta del sottoscrittore, del documento; una seconda (sec. XIV), indicata con la sigla A, che frequenta le pergamene riguardanti beni in Costa Caroliana, nell’Oltreticino; una terza (sec. XV-XVI), identificata come B, presente sul retro delle carte che menzionano beni nel territorio di Pieve Porto Morone [200].
Passando invece all’età moderna, è da segnalare un intervento del XVIII secolo, molto simile a quello presente nel verso di numerose pergamene del S. Tommaso di Pavia [201], che si limita ad apporre la data del documento. Purtroppo non ci è pervenuto alcun registro compilato da questa mano che possa conferire alle annotazioni un valore significativo. Una seconda mano segnala di aver veduto le pergamene nel 1708, accompagnando talvolta le sue affermazioni con un regesto, oppure con frasi quali: “Questo instromento non serve di presente al monastero di S. Felice”, “Instromenti … ne’ quali il monastero di S. Felice non è nominato e perciò non vagliono”. La presenza di tali annotazioni, sebbene utile per identificare le pergamene che sul recto non fanno esplicita menzione dell’ente, non sembra obbedire ad alcuna logica, in quanto non interessa la totalità delle carte bensì un numero limitato di esse, selezionate in base a criteri ignoti (né cronologici, né tematici). Inoltre anche in questo caso non ci è pervenuto, se mai esistette, il registro relativo, perciò valgono le stesse osservazioni espresse a proposito del caso precedente. Al contrario, la mano più significativa che compare sul verso delle pergamene, del 1689, finalmente trova riscontro in un registro. Sono infatti conservati presso l’ASMi due registri: uno, compilato nel 1725 [202], è purtroppo completamente inutile ai fini di questa ricerca in quanto regesta solamente documenti di età moderna, limitandosi a segnalare con poche parole la presenza di “instrumenti diversi in carta pecora”. L’altro è invece quello sopra menzionato: compilato nel 1689 [203] dalla stessa mano che annota sui versi di numerose pergamene, in assenza di testimonianze più complete ha rappresentato un importante elemento di confronto, anche se la sua particolare configurazione pone problemi di non facile soluzione.
Sul frontespizio di cartone il compilatore del registro appose il titolo: “Nota delli istromenti in carta pecora di S. Felice ed altri. | È per le acque” [204] Quindi, sulla carta 1r annotò: “Nota della sielta fatta minutamente delli instromenti antichi in carta pecora et il contenuto di essi come segue”. Nonostante questa dichiarazione di programmatica precisione, è molto difficile capire in base a quali parametri tale scelta sia stata condotta, dal momento che, come dimostrerò in seguito, il compilatore non sembra attenersi né ad un criterio cronologico né ad uno tematico nell’ordinare i documenti. Che l’anonimo abbia – purtroppo – effettuato una selezione di materiale appare evidente dal fatto che, nell’arco di tempo compreso fra il 1122 ed il 1689 (tale è infatti l’escursione temporale abbracciata dal registro), solamente 190 pergamene sono state segnalate: non viene assolutamente esaurita la totalità delle carte che erano presenti nel tabularium, come emerge con sicurezza dal fatto che molti pezzi a noi pervenuti non sono stati inclusi nell’elenco.
Il registro si occupa esclusivamente di carte private e ne regesta venticinque del XII secolo, trentacinque del XIII secolo, trentanove del XIV secolo, settantanove del XV secolo, otto del XVI secolo ed una del XVII secolo; l’ordine secondo il quale le carte sono elencate è assolutamente casuale. Ogni documento è corredato di un numero successivo, della data e di un regesto. Anche qui la confusione non manca: la serie di numeri che va da 150 a 159 è iterata, le date risultano spesso sbagliate, non solo a causa dell’incomprensione del meccanismo cronico sotteso alla formula delle calende (ad esempio, “tercio kalendas octobris” diventa 3 ottobre anzichè 29 settembre), ma anche per colpa di errori attribuibili alla distrazione o ad una cattiva lettura: così il 1128 di un documento diventa 1558 nel regesto, ed ancora, i nomi dei contraenti sono talvolta storpiati oppure confusi con nomi di persone estranee al negozio. Infine, limitando cronologicamente la ricerca sino al sec. XIII, ho individuato 14 regesti [205] di cui non sembra esserci pervenuta la pergamena corrispondente: si tratta di testimonianze molto preziose che ci permettono di colmare i “buchi archivistici” creatisi in corrispondenza di pezzi deperditi; tuttavia, nel nostro caso, considerata la disinvoltura con la quale l’anonimo confonde date e nomi, è necessario procedere con la massima cautela, per non rischiare di collocare a sproposito negozi giuridici che magari ebbero luogo in epoche precedenti o successive.
La confusione aumenta se esaminiamo le segnature apposte sul verso delle pergamene. Possiamo infatti individuare quattro categorie di annotazioni:
- 1. Annotazione consistente in un numero progressivo, seguito spesso da data e regesto. Si tratta di quelle pergamene che sono state registrate dall’anonimo nella Nota : il numero presente sul verso coincide con il numero assegnato al documento nel registro, la data ed il regesto, quando presenti, sono uguali (o per lo meno simili) a quelli annotati. Anche qui non mancano sviste clamorose: regesti non corrispondenti al reale contenuto del documento, datazioni che non solo non coincidono con la data esatta dell’atto, ma neppure fra di loro. Le pergamene facenti parte di questo gruppo sono, fino a tutto il XIV secolo, settantacinque.
- 2. Annotazione “Nichil valet” (oppure “1689 Nichil valet”). Caratterizza quelle carte che, pur essendo state viste dall’anonimo, non sono state ritenute valevoli oppure utili ai fini dello scopo previsto dal registro, e dunque non sono state incluse nell’elenco. In due casi il compilatore aggiunge in italiano, accanto al solito “Nichil valet”, “Non vale più”. Unico è il caso di una pergamena che, contrassegnata dalla scritta “Nichil valet” sul verso, corrisponde purtuttavia ad un regesto della Nota. Il numero totale di queste pergamene è venticinque.
- 3. Annotazione “1689”. Caratterizza un numero esiguo di carte (tre), che sono state viste dall’anonimo ma non catalogate nella Nota. Ho incluso in questo gruppo anche una pergamena che presentava la scritta aggiuntiva “Nichil valet” depennata. Ritengo comunque che questa annotazione abbia un significato analogo alla precedente.
- 4. Nessuna annotazione. Vi sono cinquantadue pergamene che, in quanto prive di qualsiasi tipo di segnatura di mano dell’anonimo, lasciano supporre di non essere state materialmente vedute oppure di non essere state considerate.
L’ipotesi che la Nota testimoniasse un riordinamento archivistico, avvenuto appunto nel 1689, incontra una sicura, immediata smentita nel titolo, laddove si dice che il registro è stato compilato con un fine preciso: “per le acque”. L’affermazione acquista significato se posta in relazione con l’ultimo regesto presente nel quaderno, il quale recita: “Instromento delle acque della roggia Triulza delle hore settanta due d’acqua viva che si leva dalla bocca del Naviglio con suo titolo delle dette hore 72 acquistate dal detto monastero, qual tiene di presente nelle mani il signor dottor Ravizza, consegnato dalla madre abbadessa Beccaria. L’anno 1689”. Dall’indubbia relazione che sussiste fra il titolo della Nota e quest’ultimo regesto si evince che l’intera compilazione venne redatta per avallare il documento rogato nel 1689 ed avente come oggetto le acque della roggia Triulza.
Settantadue ore d’acqua della roggia Triulza, che scorreva nel territorio di Casarile e Binasco, facevano parte del patrimonio del monastero sin dal 1504 [206], anno in cui erano state vendute all’ente dalla famiglia Trivulzio, e venivano utilizzate per irrigare i possedimenti di S. Felice siti in cascina Melone e cascina Cavagnate. Inizialmente avevo ipotizzato che la carta del 1689 avesse sancito un ulteriore negozio – acquisto o vendita (il testo del regesto è alquanto sibillino) –, intercorso fra S. Felice ed un certo dottor Ravizza ed avente come oggetto altre settantadue ore d’acqua della roggia Triulza: di qui la disamina di tutto il materiale cartaceo prodotto dal cenobio pavese e conservato in ASMi, finalizzata a reperire il documento attestante tale negozio.
Ritenevo infatti che, una volta appreso il contenuto dell’atto, avrei potuto anche cogliere le ragioni sottese alla redazione del registro, che a tale atto doveva la propria esistenza. L’indagine è stata per un verso infruttuosa (il documento non è stato rintracciato), ma per un altro verso utilissima, in quanto l’esame di innumerevoli incartamenti, minute ed appunti relativi alla roggia Triulza mi ha fornito nuovi spunti di ricerca e mi ha permesso di formulare conclusioni del tutto inattese. Innanzitutto, rileggendo attentamente il regesto del 1689, sono giunta alla conclusione che le “settantadue ore” cui esso fa riferimento non sono altro che quelle vendute al monastero dal principe Renato Trivulzio nel 1504, e l’“instromento” menzionato è quello relativo a tale acquisto. Il dottor Ravizza, come emerge da un’annotazione scritta su un foglietto rinvenuto nella cart. 853 [207], non è né un acquirente né un venditore, bensì un giurisperito, forse un procuratore del monastero, cui la badessa consegna il documento del 1504 (o una sua copia) ai fini di tutelare, nell’ambito di una controversia [208], i propri diritti sulla roggia. La Nota dunque sarebbe stata redatta esclusivamente al fine di accreditare tali diritti mediante la testimonianza di “instromenti antichi”, che conferivano ai possedimenti del monastero il lustro della vetustà, anche se, o forse proprio perché, erano difficilmente decifrabili.
Come accennavo in precedenza, il parametro di giudizio cui il compilatore si attenne nel selezionare il materiale degno di essere regestato è impenetrabile e probabilmente, benché egli affermi di aver compiuto “minutamente” la sua “sielta”, privo di qualsiasi logica. Innanzitutto è degno di rilievo il fatto che, sebbene la Nota sia stata approntata “per le acque”, sono solamente due i regesti relativi a questo argomento (di cui uno riguardante la roggia Lonara, che non ha alcuna attinenza con i luoghi in questione), e solo dodici quelli inerenti a beni in cascina Cavagnate e cascina Melone [209]. L’oggetto dei rimanenti regesti è costituito principalmente dagli immobili posseduti da S. Felice in porta Marenga a Pavia, nonché da beni siti nella campagna pavese (cf. tabella 1), che nulla hanno in comune con l’atto del 1689.
Parimenti oscuro risulta il criterio secondo il quale le carte vennero giudicate ancora valevoli o meno. Nel tentativo di individuarne la logica, ho diviso il materiale in gruppi relativi all’ubicazione dei beni che costituiscono l’oggetto del negozio, ed ho verificato quante siano, per ogni categoria di beni, le pergamene regestate dall’anonimo, quante vengano considerate non valide e quante semplicemente ignorate. Il risultato di questo tipo di ricerca, sintetizzato nella tabella, rivela che non esiste un atteggiamento univoco da parte del compilatore, il quale ritiene sì valevoli alcuni documenti, ma immancabilmente ne ritiene non validi altri facenti parte della medesima categoria. Per quanto riguarda il gruppo relativo ai beni in cascina Melone e cascina Cavagnate (beni che più direttamente si collegano ai contenuti della carta del 1689), la situazione è la seguente: nei limiti cronologici assegnati alla mia ricerca rientrano tre regesti [210], per i quali non è stata reperita alcuna pergamena corrispondente. Possediamo invece, come attesta la tabella, quattro pezzi archivistici che menzionano le due cascine o le acque ivi scorrenti, tuttavia nessuno di essi è stato segnalato nella Nota. Tale omissione costituisce la prova più evidente del mancato interesse, da parte dell’anonimo, verso un particolare gruppo di beni.
Una seconda ipotesi è stata verificata: sulla base di un’approfondita conoscenza del patrimonio del monastero il compilatore avrebbe potuto rigettare le carte relative a beni alienati in periodi precedenti, contrassegnandoli con la scritta “Nichil valet” e quindi escludendole dal registro. Anche questa chiave di lettura si è ben presto rivelata inconsistente: basti citare il caso di due carte, l’una rogata il 1209 marzo 16 e l’altra il 1219 settembre 22: in entrambe si parla di una casa, sita in Porta Marenga, che dalle coerenze risulta essere la medesima: eppure sul verso della prima compare l’annotazione “Nichil valet”, su quello della seconda è presente il numero 177 cui nel registro corrisponde un regesto.
Altre possibili ipotesi vagliate per individuare la logica sottesa alla catalogazione – che l’anonimo avesse reputato non validi i munimina in quanto in essi non compariva il nome del monastero, che avesse deciso di eliminare le pergamene in cattivo stato di conservazione, o che forse avesse operato una selezione in base al tipo di negozio giuridico registrato nei documenti – non sono state suffragate dai dati emersi in uno studio comparato delle pergamene.
Le conclusioni sono ad un tempo obbligate e sconfortanti: la Nota dovette essere redatta nel 1689 da un anonimo compilatore, provvisto di un livello di alfabetizzazione assai scarso, come si può inferire dalla sintassi zoppicante di titolo, premesse, regesti [211], nonché quasi incapace di leggere gli “instromenti antichi” che era stato incaricato di regestare in vista di una controversia. Tali “instromenti” vennero dunque selezionati in base ad un criterio “barbaro”, che non ha tenuto conto della loro attinenza con i beni oggetto della controversia, bensì esclusivamente del fatto che fossero “in carta pecora”, e/o forse del fatto che fossero più o meno leggibili. Questa arbitrarietà di metodo e di giudizi è parzialmente imputabile al breve periodo concesso all’anonimo per svolgere il suo compito, attestato dalle due date croniche annotate sul quaderno: la più antica, che con ogni probabilità indica l’inizio del lavoro, è apposta sulla carta 1r e recita: “1689 c(orrente) 2 luglio”; la più recente, “1689 c(orrente) 26 agosto in Milano”, venne aggiunta invece sulla carta Iv, a conclusione della compilazione, quando il registro venne esibito al dottor Ravizza in accompagnamento al documento del 1504. Un lasso di tempo di un mese e mezzo è indubbiamente troppo esiguo ai fini di una lettura, comprensione, catalogazione e regestazione di tutte le carte menzionate nella Nota. La fretta e la superficialità con cui lo spoglio venne condotto, unite alla mancanza di perizia, sono argomenti sufficienti per motivare gli errori di datazione e di interpretazione, nonché le gravi carenze nell’organizzazione del lavoro.
5. I documenti
5.1. La tipologia
La tipologia delle carte presenta una notevole varietà, riscontrabile principalmente negli esemplari prodotti dal XIII secolo in poi, in concomitanza con la nascita e la definizione di nuove, molteplici categorie di negozi. La tipologia documentaria più frequente è indubbiamente quella dell’investitura, che da sola esaurisce più di un terzo degli atti complessivi; seguono, in numero molto più ridotto, le carte venditionis. Dal momento che i documenti del XII secolo sono solamente 38, numericamente esigue sono le categorie tipiche di quest’epoca, come i livelli, che, definitivamente scomparsi dopo il 1174 [212], già di per sé “costituiscono nell’arco del secolo XII una minima parte della documentazione pervenuta” perché il fatto di venire utilizzati come coperture ad alienazioni di beni ecclesiastici ne ostacolava la diffusione [213]. Rare sono anche le refute e le donazioni. Meno rare sono invece le carte ad instrumentum autenticandum, diffusesi in Pavia attorno alla prima metà del secolo XIII secondo questa prassi: un privato (ma sono i casi più precoci e rari) o, solitamente, un’autorità pubblica richiedeva al notaio di trarre una copia da documento già esistente e di autenticarla con la propria sottoscrizione [214]. Delle dieci carte (sei fino alla fine del sec. XIII) conservate nell’archivio di S. Felice, la maggioranza è redatta su comando del console di giustizia; una è invece redatta in base al preceptum della stessa badessa del monastero [215].
Categorie di documenti che compaiono solo a partire dal XIV secolo sono la carta licentie, con la quale il vescovo concede al monastero il permesso di effettuare permute o investiture perpetue, nonché il tractatus, ovvero le tre delibere consecutive, unite da un’unica completio, con le quali il capitolo del monastero stabilisce di concedere un’investitura perpetua. Il progressivo impoverimento dei beni immobiliari ecclesiastici, attribuibile all’impatto negativo che le investiture soprattutto perpetue avevano su tale patrimonio ed in generale alle spoliazioni effettuate ad opera dei potenti soprattutto nei secoli XIV-XV [216], fu la causa che determinò la nascita di questi nuovi tipi documentari. Infatti, poiché numerosissime disposizioni canoniche erano state approntate per “difendere la proprietà ecclesiastica da usurpazioni … del potere secolare”, si rese necessaria una licenza vescovile ogni qualvolta un ente desiderasse contravvenire a tali disposizioni: la situazione è già stata studiata nel caso di Milano, ove l’arcivescovo forniva il proprio assenso “non solo nelle alienazioni vere e proprie, ma anche nelle permute e nelle concessioni enfiteutiche” [217]. La stessa congiuntura generò probabilmente i tractati, delibere ragionate che dimostravano come il capitolo del monastero, prima di concedere un’investitura, ne avesse attentamente valutato le caratteristiche e fosse persuaso della loro utilità [218].
A completamento della tabella 2 ho apposto alcune note in cui vengono elencati i documenti assegnati ad ogni singola tipologia, specificando i titoli delle carte comprese nelle categorie “Atti giudiziari” e “Vari”.
5.2. La datazione
Come in tutti i documenti privati pavesi [219], anche nelle carte di S. Felice i notai, sino alla metà del secolo XII, per il computo della data utilizzarono lo stile della natività unito all’indizione settembrina (greca o bedana) [220]; nella seconda metà del secolo si consolidò invece la prassi che sostituiva alla settembrina l’indizione pontificia, poi usata per tutto il medioevo. Il cambiamento è testimoniato da un breve refutationis del 1148 [221] che, pur essendo datato settembre 29, non presenta più il consueto sfasamento fra anno ed indizione. Il giorno della settimana, da sempre introdotto nei brevi, si afferma definitivamente in tutte le tipologie di documenti con il sorgere del regime di instrumentum (seconda metà del secolo XII). Negli ultimi decenni del secolo XIV assistiamo però ad una sua progressiva scomparsa. Il giorno del mese è computato con il sistema misto delle calende (seconda metà del mese) e moderno (prima metà), ma nella seconda metà del secolo XIII si affermerà l’uso esclusivo del sistema moderno [222].
Nell’introduzione ai singoli documenti non ho mancato di segnalare e spiegare eventuali casi di discrepanza fra i diversi dati cronici.
5.3. Il rapporto mundum / imbreviatura
Un’ampia, esauriente trattazione del rapporto fra mundum ed imbreviatura presso i notai pavesi è stata recentemente presentata da Barbieri [223]. Rinviando al suo lavoro per ogni questione a carattere generale, mi soffermerò sulle osservazioni che in proposito è possibile desumere dai documenti qui editi.
Anche nella presente silloge sono presenti alcune carte tratte da imbreviature di notai defunti [224]: la più antica è del 1211, anno in cui ormai tale prassi era ampiamente diffusa presso i professionisti pavesi.
5.4. I regesti del 1689
Questi problematici regesti, che, come ho specificato nel paragrafo 4.2, peccano spesso di imprecisione, e talvolta presentano errori sia nella datazione sia nell’individuazione degli attori del negozio, non sono risultati di facile collocazione. Infatti, benché i 23 regesti di cui non è pervenuta la pergamena corrispondente siano testimonianze significative che ci permettono di colmare i “buchi” creatisi in corrispondenza dei pezzi deperditi, la loro non perfetta attendibilità dava adito a due possibilità: fornire anch’essi di numero progressivo e collocarli al loro posto fra i documenti, oppure, considerate le loro carenze, escluderli dal corpus. La seconda soluzione mi è sembrata però troppo drastica, poiché avrebbe implicato l’esclusione aprioristica di tutti i pezzi, anche di quelli correttamente redatti. Inoltre, in mancanza di notizie più precise, questi regesti potevano fornire informazioni comunque interessanti sui beni e sui negozi del monastero. Pertanto ho deciso di collocare i pezzi al loro posto, specificando tuttavia per ogni singolo caso le possibili varianti della data, dal momento che l’anonimo non prende in considerazione l’uso del sistema delle calende per indicare il giorno del mese. Nei casi in cui il contenuto era analogo, ma non identico, a quello di documenti pervenuti, ho spiegato di volta in volta le motivazioni che mi hanno spinto ad attribuire il regesto ad un documento oppure a separarlo da esso. È d’obbligo comunque segnalare in questa sede la cautela con cui vanno considerate le informazioni forniteci da tutti questi pezzi sui generis.
5.5. Criteri di edizione
Per i criteri di edizione mi sono attenuta alle norme stabilite dall’Istituto Storico Italiano [225], successivamente riprese da Pratesi [226]. Rinvio inoltre al volume Le carte di S. Pietro in Ciel d’Oro, II, che ha costituito un modello concreto cui ispirarsi, nel rispetto di tali norme e con l’aggiunta di marginali innovazioni. Ritengo utile precisare qui le più significative.
L’uso delle parentesi angolari nel titolo e nella datatio sta ad indicare la presenza di una congettura da parte dell’editore, basata su dati oggettivi che si desumono dal contesto o dagli usi del notaio in altre carte; le parentesi quadre indicano invece semplici integrazioni. Il titolo è tratto, per quanto possibile, dalla completio, vengono inoltre riportate tra parentesi tonde eventuali ulteriori definizioni del documento che compaiano in altro luogo.
In ossequio a un criterio di omogeneità ho attribuito un titolo a tutti i documenti dell’edizione, benché a partire dal secolo XIII si elaborino nuove tipologie negoziali più difficili da definirsi attraverso la schematicità di pochi vocaboli.
Nei regesti i nomi propri sono stati tradotti in italiano, i cosiddetti “cognomi”, benché tale appellativo non possa ancora essere utilizzato a pieno titolo nel medioevo, sono invece stati conservati in latino. Tale criterio è stato mantenuto, per motivi di uniformità, anche nei regesti relativi ai pezzi del 1689, benché tali pezzi siano redatti in volgare.
Nell’edizione dei documenti è stata utilizzata la maiuscola dopo il punto fermo. Per motivi tecnici la e cedigliata è stata sostituita dalla e, ed i tre asterischi verticali indicanti la presenza del carattere allungato dal singolo asterisco. Le integrazioni del testo e delle annotazioni tergali operate grazie alla lampada di Wood non sono state riportate fra parentesi quadre.
Il criterio di separare gli inserti dai documenti che li contengono è stato puntualmente osservato, eccezion fatta per le sentenze di cui ai nn. 120, 138. In questi casi infatti, per non danneggiare la comprensione del negozio nella sua intierezza, ho preferito non separare dal contesto il libellus petitionis ed il consilium iudicis, collocando a parte, come pezzi a sé stanti, i loro regesti, disposti secondo il loro normale ordine cronologico.
L’identificazione dei numerosi toponimi, microtoponimi ed istituzioni ecclesiastiche è stata condotta tenendo conto in primo luogo dei dati forniti dalle tavolette al 25.000 dell’Istituto Geografico Militare, nonché di documenti editi e inediti, opere storiografiche, testimonianze orali, repertori di toponomastica [227].
Note
[1] Già nell’851, nel diploma di cui alla nota 18, si specifica che S. Felice, insieme ad altri enti religiosi, è governato “secundum regularem institutionem S. Benedicti”. Per testimonianze relative alle epoche successive cf. GIANANI, Opicino, p. 124, ove il cenobio è detto “monasterium nigrarum”. Cf. anche docc. nn. 170, 212, 216, 231, 236. Cf. inoltre CIPARELLI, Studio storico-diplomatico, pp. 1-8.
[2] Cf. i documenti conservati in ASMi, Culto p.a., cart. 1961.
[3] Cf. BERENGO-GARDIN, Il monastero di S. Felice, pp. 33-35.
[4] MAIOCCHI, Le chiese, p. 24.
[5] Cf. note 40, 43.
[6] Cf. nota 13.
[7] Cf. GASPARRI, Pavia longobarda, p. 63.
[8] Cf. BRÜHL, CDL, III, n. 33, p. 208.
[9] Cf. BRÜHL, CDL, III, n. 40, p. 237.
[10] L’ultima attestazione è del 1043, cf. doc. n. 7.
[11] Cf. diploma di Desiderio del 759 gennaio, in BRÜHL, CDL, III, n. 31, p. 189; cf. anche BROGIOLO, Trasformazioni urbanistiche, p. 203, che prende in considerazione, fra altre ipotesi, l’esistenza di un monastero antecedente al S. Salvatore ed intitolato a questi santi.
[12] GIANANI, Opicino, p. 165. Cf. anche docc. nn. 64, 108.
[13] PESSANI, Dei palazzi, pp. 149-160, e sulla sua scia VACCARI, Una sepoltura regale, p. 139.
[14] Cf. MGH, P. DIACONUS, Historia Langobardorum, VI, cap. 58, p. 186.
[15] Diverso quindi da quello edificato da Teodorico e distrutto dai pavesi nel 1024, che si trovava in prossimità della porta Palacense, in corrispondenza dell’odierna via Scopoli; cf. HUDSON, Pavia: l’evoluzione urbanistica, pp. 242-245.
[16] Sostenuta anche dal BRÜHL, Das Palatium, pp. 203-206.
[17] Cf. ROMANO, Di un supposto palazzo reale, pp. 133-154 e, più recentemente, SETTIA, Pavia carolingia, p. 105 e nota 32.
[18] MGH, D. Loth. I, n. 115, p. 266.
[19] Cf. doc. n. 9.
[20] BENASSI, CDP, I, n. 10, p. 120.
[21] Di diversa opinione è CROTTI PASI, Il sistema caritativo, p. 364, che nega una possibile coincidenza fra i due ospizi, osservando che nel contesto del diploma di Ludovico II S. Maria Britonum non è menzionata unitamente a S. Felice, mentre nella concessione di Desiderio ed Ansa si specificava la contiguità dei due edifici. Ritengo però che la comune dipendenza dei due xenodochi da S. Salvatore di Brescia sia comunque elemento che depone a favore della loro identificazione.
[22] MGH, D. Arn., n. 49, p. 69.
[23] Sulle motivazioni di questa denominazione cf. PANAZZA-BROGIOLO, Ricerche, p. 31.
[24] SCHIAPARELLI, I diplomi di Guido, n. 7, p. 17.
[25] Cf. ARSLAN, L’architettura, p. 526.
[26] Cf. PERONI, Per la tipologia, pp. 90-92, p. 95 nota 13, p. 98.
[27] Quest’anno è considerato punto di riferimento perché dell’851 è il diploma più antico cui l’autore si rifà, ignorando che anche nelle concessioni di Ansa e Desiderio è menzionato il monastero.
[28] Cf. VICINI, La civiltà, p. 338.
[29] Cf. HUDSON, Pavia: l’evoluzione, p. 254.
[30] Cf. ROBOLINI, Notizie, II, p. 137; MAIOCCHI, Le chiese, p. 5.
[31] Cf. HUDSON, Pavia: l’evoluzione urbanistica, passim.
[32] Cf. MABILLON, Annales, III, pp. 173-174; VACCARI, Una sepoltura regale, pp. 138-139.
[33] Cf. nota n. 20 e testo ad essa corrispondente.
[34] Cf. GIANANI, Opicino, p. 207, nota 194.
[35] Cf. MILANI, Intorno alla organizzazione, pp. 131 ss.
[36] Cf. ROBOLINI, Notizie, II, p. 138; MILANI, Intorno alla organizzazione, p. 139.
[37] Cf. VIOLANTE, La società milanese, p. 13.
[38] Cf. doc. n. 2.
[39] GIANANI, Opicino, p. 124. Già il Catalogo Rodobaldino, elenco di corpi santi risalente al 1231, ricordava la presenza delle reliquie di s. Felice nel monastero, tuttavia la tormentata tradizione del testo ha fatto sì che diversi manoscritti fornissero versioni diverse, designando alternativamente Felice come semplice santo, come martire, come vescovo e martire: cf. BONI-MAIOCCHI, Catalogo Rodobaldino, p. 29 e nota 2.
[40] GUALLA, Historiae suae patriae, p. 96, cap. XIV.
[41] BREVENTANO, Istoria della antichità, p. 95.
[42] Cf. BOSSI, Le glorie sacre, parte I, cc. 78v-79r e, della sua medesima opinione, DE GASPARIS, Diario sacro e profano, p. 74; PETRAGRASSA, Laureolae sacrae, p. 15; UGHELLI, Italia Sacra, I, col. 1078.
[43] GHISONI, Flavia Papia Sacra, I, p. 84.
[44] Cf. CAPSONI, Memorie istoriche, II, p. 95; ROBOLINI, Notizie, II, p. 136, nota 1.
[45] Cf. SAVIO, Gli antichi vescovi, La Lombardia, vol. II, pp. 332 ss.; HOFF, Pavia und seine Bischöfe, tabella alle pp. 1-6 e pp. 41-55; LANZANI, Ticinum, pp. 356-364.
[46] Attestato anche dai docc. nn. 3, 4.
[47] Cf. OSWALD-SCHAEFER-SENNHAUSER, Vorromanische Kirchenbauten, passim, ove sono citati esempi di chiese che, in concomitanza con l’arrivo di nuove reliquie o con ampliamenti dell’edificio assunsero nuove intitolazioni o le aggiunsero alle precedenti.
[48] Cf. PERONI, Per la tipologia, p. 90.
[49] Cf. BONI-MAIOCCHI, Catalogo Rodobaldino, p. 28.
[50] Cf. ROBOLINI, Notizie, IV, parte I, p. 415. In effetti il testo che ispirò l’iscrizione risulta databile alla prima metà del secolo XV: v. infra.
[51] Il testo della lapide è trascritto anche in BOSSI, Memoriae Ticinenses, c. 60r.
[52] Cf. GUALLA, Historiae suae patriae, p. 94, cap. XI.
[53] Cf. BREVENTANO, Istoria della antichità, p. 95.
[54] Cf. BOSSI, Le glorie sacre, p. 79r.
[55] Cf. GHISONI, Flavia Papia Sacra, I, p. 84.
[56] E la sua interpretazione verrà ripresa da numerosi altri: cf. DELL’ACQUA, Dell’insigne, p. 119; VALLE, Le reliquie, p. 44.
[57] Cf. MURATORI, Annali, V, p. 456; BÖHMER, Die Regesten unter Otto II, n. 823a; MGH, D.O. II, n. 237, p. 265.
[58] Con eccezione del DE GASPARIS, Diario sacro e profano, p. 74, che ascrive la costruzione del cenobio ad Ottone I, probabilmente per un’errata lettura degli antigrafi.
[59] Cf. note nn. 8-9, 18, 20, 22, 24.
[60] Per una descrizione più dettagliata del Registrum v. nota 200.
[61] Cf. MAIOCCHI, Le chiese, II, p. 9.
[62] Cf. DELL’ACQUA, Dell’insigne, p. 118.
[63] Cf. doc. n. 4.
[64] Cf. GUALLA, Historiae suae patriae, pp. 94 ss, capp. XI-XII; BREVENTANO, Istoria della antichità, p. 95; GHISONI, Flavia Papia Sacra, I, p. 84.
[65] BONI-MAIOCCHI, Catalogo Rodobaldino, p. 28.
[66] Cf. GIANANI, Opicino, p. 109, dove in una tavola preliminare alla stesura dell’opera è menzionata fra i “corpora reginarum” anche “Felicitas”.
[67] “… iacet corpus S. Felicitae filiae praedicti imperatoris <Ottone II, cf. p. 11> quae dum adire deberet maritum suum monasterium istum intravit in quo vitam suam sanctissime finivit et quievit”.
[68] Cf. BÖHMER, Die Regesten unter Otto II, n. 749a.
[69] Cf. MGH, D.O.II, p. 926 (alla voce Adalheida) e p. 970 (alla voce Sophia); BÖHMER, Die Regesten unter Otto II, n. 823a.
[70] Cf. BÖHMER, Die Regesten unter Otto III, nn. 749a, 1017e, 1328a, 1717.
[71] Cf. MGH, D. O. III, pp. 955 (alla voce Mathilda) e 963 (alla voce Quitilinburg).
[72] Cf. VALLE, Le reliquie, pp. 44 ss.; MAIOCCHI, Le chiese, p. 9.
[73] Cf. doc. n. 5 ove il monastero è significativamente menzionato con l’appellativo “S. Gerorgii” <Così>.
[74] MGH, D. O. II, p. 327, n. 281. Sull’attività di Adelaide e Maiolo cf. COLOMBO, I diplomi ottoniani, pp. 3-21; CASAGRANDE, I cluniacensi, pp. 51-54, dove, passando in rassegna gli enti pavesi riformati da s. Maiolo, l’autrice significativamente non allude mai a S. Felice.
[75] Cf. BONI-MAIOCCHI, Catalogo Rodobaldino, p. 30.
[76] Cf. PORRO-LAMBERTENGHI, Codex Diplomaticus Langobardiae, coll. 1754 ss. Il fatto che i documenti siano probabilmente spuri complica ulteriormente l’indagine e richiederà in futuro accertamenti e approfondimenti che per ora non è stato possibile compiere; tuttavia la loro stessa esistenza è degna di nota per almeno due validi motivi: perché è risaputo che un falso rispecchia generalmente una realtà storica conclamata, forse di epoca più tarda ma comunque significativa, e perché comunque in questi documenti S. Salvatore fuori le mura è definito in modo tale da renderlo quasi perfettamente confondibile con S. Felice: in entrambi i casi si tratta di un monastero del Salvatore ove giace il corpo di un s. Felice; la differenza è limitata alla diversa collocazione fuori e dentro le mura.
[77] Doc. n. 2.
[78] Docc. nn. 3, 4.
[79] Cf. doc. n. 3.
[80] Cf. docc. nn. 4, 6.
[81] Cf. doc. n. 8 e segg.
[82] Per la descrizione dettagliata di questi possedimenti v. cap. 3.
[83] MGH, D Ko. II, n. 38, p. 42.
[84] MGH, D Ko. II, n. 118, p. 164.
[85] Cf. doc. n. 7.
[86] Cf. diploma del 1060 aprile 13 in MGH, D H. IV, n. 63, p. 83.
[87] Cf. COGNASSO, Storia di Novara, p. 95.
[88] Cf. GHISONI, Flavia Papia Sacra, I, p. 85.
[89] La FORZATTI GOLIA, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 243, sostiene erroneamente che in un diploma del 1092 Enrico IV avrebbe confermato il privilegio della giurisdizione al cenobio: in realtà l’ente destinatario della concessione è il monastero di S. Marino e Leone, cf. MGH, D. H IV, n. 429, p. 575.
[90] Cf. doc. n. 8.
[91] Cf. GIANANI, La Charta Consuetudinum, p. 38.
[92] Cf. privilegio del 1206 giugno 12 in MIGNE, Patrologiae, vol. 215, p. 906.
[93] 1123 aprile 15, in KEHR, Regesta, vol. VI, parte I, n. 33, p. 180.
[94] 1130 agosto 7, in KEHR, Regesta, vol. VI, parte I, n. 34 p, 181.
[95] Cf. note 113, 120, 121, 122.
[96] Cf. GABBA, La storiografia pavese, p. 11.
[97] Cf. BONI-MAIOCCHI, Catalogo Rodobaldino, p. 28.
[98] Cf. BONI-MAIOCCHI, Catalogo Rodobaldino, p. 10. È stata recentemente individuata una copia ancora più antica, risalente alla metà del secolo XIV, di cui Boni e Maiocchi non erano a conoscenza, cf. ZAMBARBIERI, La vita religiosa, p. 304.
[99] Cf. ANONYMI TICINENSIS, Liber de laudibus; GIANANI, Opicino.
[100] Cf. GABBA, La storiografia pavese, pp. 11-12.
[101] Cf. GIANANI, Opicino, pp. 111-112.
[102] Cf. GIANANI, Opicino, p. 164.
[103] Quest’ultima però viene ricordata da Opicino in altra sede, fra i “corpora reginarum”: cf. GIANANI, Opicino, p. 109.
[104] Per ulteriori informazioni sui caratteri dell’opera cf. il già citato, esauriente saggio di GABBA, La storiografia pavese, pp. 12-14.
[105] Cf. CAPSONI, Memorie istoriche, II, p. XII ss.
[106] Cf. GUALLA, Historiae suae patriae, pp. 94 ss.
[107] Cf. paragrafo 1.3 di questa introduzione.
[108] Cf. CAPSONI, Memorie istoriche, II, p. XV.
[109] Cf. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XIII, p. 307.
[110] Cf. CAPSONI, Memorie istoriche, II, p. XV.
[111] Cf. BOSSI, Le glorie sacre, I, cc. 78v-79r.
[112] Cf. BOSSI, Memoriae Ticinenses, c. 60r.
[113] MABILLON, Annales, III, p. 173.
[114] Cf. nota 20.
[115] Cf. nota 22.
[116] Cf. …
[117] CAPSONI, Memorie istoriche, II, p. XVII.
[118] Cf. GHISONI, Flavia Papia Sacra, p. 9.
[119] Cf. nota 22.
[120] MURATORI, Antiquitates Italicae, III, coll. 639 e ss., 741 e ss.; IV, col. 197 e ss.; V, col. 521 e ss.
[121] MURATORI, Antichità Estensi, I, pp. 110 e ss., 125 e ss.
[122] Cf. MURATORI, Antiquitates Italicae, V, col. 522.
[123] Cf. ROBOLINI, Notizie, II, pp. 135-138.
[124] Cf. MAIOCCHI, Le chiese, II, pp. 5-28.
[125] Esistono due tesi di laurea, inedite, dedicate a S. Felice: la prima, di CIPARELLI, Studio storico-diplomatico, pur presentando un coacervo di informazioni disordinate e talvolta discordanti fra loro, è una vera miniera di indicazioni bibliografiche; la seconda, di MAZZOLARI, Le carte, è un’edizione critica di documenti e non fornisce nuove indicazioni rispetto a quanto da me esposto. Fra i contributi che hanno in qualche modo trattato argomenti relativi a S. Felice, oltre a quelli già citati nel capitolo 1 di questa introduzione, ricordo ancora: LANZANI, Le concessioni, pp. 46-49, sui privilegi concessi al cenobio e sulle sue denominazioni, seppure non sempre attendibile e preciso; BIANCOLI, La chiesa di S. Felice, p. 3; CAPITANI, Chiese e monasteri, pp. 126 e 141; VERZONE, L’architettura religiosa, pp. 155-56.
[126] Cf. MAIOCCHI, Le chiese, p. 15. Fonte di tali informazioni sono le imbreviature del notaio vescovile Albertolus de Griffis, conservate nell’Archivio di Stato di Pavia, di cui intraprenderò fra breve lo spoglio.
[127] Cf. docc. nn. 23, 40, e doc. 1334 maggio 31, Pavia (in copia autentica del 1360 novembre 9, Pavia), ASMi, FR p.a., cart. 5985.
[128] La località compare già fra i territori concessi da Enrico II nel 1014: cf. doc. n. 6.
[129] Doc. n. 14.
[130] Cf. annotazioni a doc. n. 84.
[131] Cf. docc. nn. 14, 84, 95.
[132] GIANANI, Opicino, p. 202.
[133] Si tratta di località situate a sud-est di Pavia, sulla riva sinistra del Po, là dove il fiume costituisce il confine fra Lombardia ed Emilia Romagna.
[134] Doc. n. 15.
[135] Cf. doc. n. 22.
[136] È la nota “Propriis de la Plebe”, del secolo XV-XVI, che frequenta il dorso dei documenti relativi a tale zona.
[137] Cf. doc. n. 51.
[138] Cf. anche doc. n. 59.
[139] Cf. docc. nn. 52-57; 61, 62.
[140] Doc. n. 60.
[141] Docc. nn. 74, 87, 92.
[142] Monastero benedettino fondato in età longobarda presso Corteolona e dotato di numerosissimi beni da re ed imperatori nei secoli successivi. Cf. KEHR, Regesta, vol. VI, parte I, pp. 224-226 e bibliografia ivi citata. Cf. anche MASCHERONI, L’abbazia benedettina, passim.
[143] Secondo la tradizione discendenti da Bernardo re d’Italia, anche se la continuità della dinastia è stata negata da HLAWITSCHKA, Franken, pp. 232-33. Nel secolo XII furono infeudati dei beni di Rovescala dal vescovo di Pavia; cf. FAGNANI, I Bernardingi, pp. 149-155; MASCHERONI, La Pieve, pp. 22-25.
[144] Doc. 1353 aprile 9, Pieve Porto Morone (originale, ASMi, AD, pergg., S. Felice, cart. 643, fasc. 268a).
[145] Cf. doc. n. 6.
[146] Cf. capitolo 4.
[147] Doc. 1318 luglio 29, cascina Melone (originale, BUPv, pergg. Comi, n. 20).
[148] Doc. <1338> novembre <…>, 12 e 28 (originale, ASMi, FR p.a., cart. 5984).
[149] Doc. n. 18. Tuttavia sulla scarsa attendibilità di tali regesti cf. qui.
[150] Doc. n. 77.
[151] Doc. 1353 maggio 25, cascina Melone (originale, ASMi, AD, pergg., S. Felice, cart. 643, fasc. 268 a).
[152] Cf. docc. nn. 38, 50.
[153] Cf. docc. nn. 25, 28, 29, 30, 31, 37.
[154] Cf. doc. n. 23.
[155] Cf. doc. 40 dove si parla di un “molandinus inferior”, e doc. cit. alla nota 127.
[156] Cf. docc. 1387 maggio 12, Pavia (originale, ASMi, AD, pergg., S. Felice, cart. 644, fasc. 268b); 1398 dicembre 7, Pavia (originale, ivi); 1399 dicembre 30, Pavia (originale, BUPv, pergg. Comi, n. 67).
[157] Cf. GIANANI, Opicino, p. 165.
[158] BARBIERI, L’archivio antico di S. Pietro in Ciel d’Oro, pp. 37-74.
[159] BARBIERI, Il monastero di Santa Maria de Ortis, pp. 407-37.
[160] ANSANI, Le carte di S. Maria di Morimondo, pp. XXVII-XLVI.
[161] BARBIERI, Per l’edizione del fondo di S. Giulia, pp. 49-92.
[162] Con il termine “pergamene” intendo indicare il numero dei pezzi archivistici recuperati e non quello dei documenti effettivi che compongono l’edizione: le cifre infatti differiscono, poiché una pergamena può ospitare più documenti, e poiché fra i documenti si includono anche regesti, vergati su materiale cartaceo anzichè membranaceo, dei quali non è pervenuto il documento corrispondente.
[163] Cf. ROBOLINI, Notizie, II, pp. 57-58 e 91-93; CAU-CASAGRANDE, Cultura e scrittura, p. 178; SETTIA, Pavia carolingia, pp. 70-73.
[164] GHISONI, Flavia Papia Sacra, I, p. 84.
[165] BOLLEA, Documenti degli Archivi di Pavia, pp. XIV-XVI
[166] L’Archivio iniziò ad essere trasferito nel Palazzo del Senato, sua attuale sede, nel 1851, ad opera di Luigi Osio; cf. A. R. NATALE, Lezioni di archivistica, Pt. II., pp. 5-6.
[167] NATALE, Lezioni di archivistica, p. 158 e ss.; cf. anche NATALE, Il Museo Diplomatico, vol. I, pt. I, pp. VII ss.
[168] Cf. NATALE, Lezioni di archivistica, p. 131.
[169] L’Archivio Diplomatico, fondato nel 1807 su istanza del Bossi e del Daverio, si articola nelle seguenti sezioni: Museo Diplomatico, Diplomi e Dispacci Sovrani, Bolle e Brevi, Pergamene per Fondi; cf. NATALE, Lezioni di Archivistica, p. 131, pp. 240-251. Un Catalogo generale delle pergamene dell’Archivio Diplomatico spettanti al secolo duodecimo è stato compilato nella prima metà del secolo scorso da L. Ferrario e G. Cossa, e “resta ancor oggi l’unico strumento per la ricerca delle pergamene posteriori all’anno 1100 relative ai singoli monasteri”, cf. BARBIERI, L’archivio antico di S. Pietro in Ciel d’Oro, pp. 44-45.
[170] Il Museo Diplomatico venne fondato nel 1852 dall’allora direttore dell’Archivio Luigi Osio; cf. NATALE, Lezioni di archivistica, p. 250-251.
[171] La sezione Pergamene per Fondi, costituita a partire dal 1816, annovera materiale prodotto fra i secoli XII-XVIII; cf. NATALE, Lezioni di archivistica, p. 132.
[172] Sulla suddivisione fra parte antica e parte moderna, cf. NATALE, Lezioni di archivistica, p. 189-190.
[173] Doc. n. 1.
[174] Cf. SERGI, Movimento signorile, pp. 157 ss.
[175] Doc. n. 2.
[176] Docc. nn. 3 e 4.
[177] Cf. NATALE, Lezioni di archivistica, pp. 250-251.
[178] D O. III, p. 846, n. 413. La carta è conservata in ASMi, Museo Diplomatico, cart. 11, n. 4 (segnatura vecchia: sec. XI, n. 347).
[179] Tutti i documenti di S. Felice conservati nel Museo Diplomatico vennero inclusi nel fondo in epoca successiva rispetto agli altri: l’inserimento posteriore era testimoniato, nella segnatura originaria ormai sostituita da altra più recente, dalla presenza di 1/2 dopo il numero di serie. Nel presente caso invece i due diplomi di S. Felice vennero aggregati ad un terzo diploma ottoniano (cf. nota precedente) e corredati del medesimo numero di quello, il 347.
[180] Doc. n. 5.
[181] Doc. n. 6.
[182] Doc. n. 7.
[183] Cf. note 8, 9, 18 e testo ad esse corrispondente.
[184] Cf. rispettivamente note 20 e 22 e testo ad esse corrispondente.
[185] Cf. BENASSI, Codice Diplomatico cit., p. XXV.
[186] Cf. nota 24 e testo ad essa corrispondente.
[187] Le pergamene di S. Maria di Monteoliveto conservate nella cartella 643 sono sette, risalenti al XIII secolo e mescolate indistintamente a quelle di S. Felice. Sono presenti inoltre quattro fascicoli di testimonianze relativi ad una controversia fra i monasteri di Monteoliveto e del Senatore. Nella cartella 644 le membrane di Monteoliveto, questa volta conservate separatamente rispetto a quelle di S. Felice, sono dieci per il XIII secolo e ventuno per il XIV secolo.
[188] Le altre pergamene della cartella sono relative al fondo di S. Maria del Carmine: una per il secolo XII, due per il secolo XIII, quarantaquattro per il XIV e venticinque per il XV.
[189] Le pergamene sono così distribuite: una per il sec. XII (n. 2 nell’Inventario delle pergamene della R. Biblioteca Universitaria di Pavia redatto da Giovanni Bertolani); tre per il sec. XIII (nn. 7, 9, 15); otto per il sec. XIV (nn. 20, 22, 25, 26, 27, 37, 58, 67).
[190] BOLLEA, Documenti degli Archivi di Pavia, p. XVI.
[191] Si tratta di due pergamene del XIII sec. (nn. 11 e 20 dell’Inventario).
[192] Le pergamene sono così distribuite: due per il sec. XII (nn. 2 e 3 dell’Inventario), sette per il sec. XIII (nn. 4, 5, 7, 11, 13, 14, 24), tre per il sec. XIV (nn. 29, 30, 35).
[193] AA. VV., Il bicentenario, pp. 7, 44, 48.
[194] Rispettivamente ai nn. 2935, 2947 e 2993, vol. IV, dell’Inventario delle pergamene della Biblioteca Ambrosiana redatto da A. Bianchi.
[195] Detto anche Codice Malabaila, è databile attorno alla metà del secolo XIV ed è copia del più antico Codice Alfieri, redatto attorno al 1292, che conteneva “gli atti, … i trattati pubblici, i diplomi e le lettere imperiali e papali, le confederazioni e le paci cogli altri Comuni…, gli acquisti, le cessioni, le sottomissioni…” del comune di Asti; cf. SELLA, Codex Astensis, I, p. 8.
[196] Cf. SELLA, Codex Astensis, III, pp. 899-918.
[197] Cf. doc. 1328 novembre 15, Pavia originale, ASMi, FR p.a., cart. 5981).
[198] Cf. BARBIERI, L’archivio antico di S. Pietro in Ciel d’Oro, pp. 39-43; BARBIERI, Per l’edizione del fondo di S. Giulia, pp. 51-54.
[199] Cf. ANSANI, Le carte di Morimondo, pp. XXIX-XLII.
[200] Esiste nella Biblioteca Universitaria di Pavia, ms. Ticinesi 362, un registro, il cui titolo recita: “Registrum investiturarum descriptarum in presenti libro monasterii S. Felicis Papiensis ordinis observantie sancti Benedicti”, che non testimonia un riordinamento archivistico ma una semplice inventariazione delle investiture, regestate in latino. Si tratta di un registro membranaceo costituito da 63 carte precedute e seguite rispettivamente da tre e due fogli di guardia. Fino a metà della carta 15v la mano scrivente è del 1490, successivamente ne subentrano altre dei secoli XVI e poi XVII. Le investiture inventariate sono tutte tarde: solo tre risalgono al XIV secolo, mentre le altre appartengono ai secoli successivi, fino al XVII.
[201] La mano è quella di Vincenzo Maria Rilucenti che nel 1774 compilò gli Annali del convento di S. Tommaso, finalizzati a “sottolineare momenti significativi della storia dei Domenicani”, registrandovi quelle carte dell’archivio del S. Tommaso che si confacevano a tale scopo; cf. BARBIERI, L’archivio antico di S. Tommaso, pp. 49-61. Le due mani sono molto simili, tuttavia non dobbiamo dimenticare che i compilatori del XVIII secolo sono spesso calligrafi la cui grafia si conforma a standards ben precisi.
[202] Registro dell’Archivio di Scritture dell’Imperial Monastero di S. Felice, ASMi, Fondo Religione parte antica, cart. 5978.
[203] Nota delli istromenti in carta pecora di S. Felice. | È per le acque, ASMi, Fondo Religione parte antica, cart. 5978. Si tratta di un fascicoletto cartaceo con copertina di cartone, composto da 22 carte di cui Ir e XVr -XXIIv bianche. Le carte 1-11 sono numerate sul recto, nell’angolo superiore destro. Seguono, inseriti nello stesso fascicolo, due documenti cuciti alla copertina: il primo, del 1705, riguarda beni posseduti da S. Felice nella parrocchia di S. Maria Gualtieri; l’altro, del 1547, è relativo ad una controversia avuta dal monastero con un privato, Giovanni Angelo Coiro, per le acque della roggia Triulza.
[204] Sull’interpretazione del titolo mi soffermerò in seguito.
[205] Docc. nn. 11, 13, 17, 18, 36, 39, 42, 48, 49, 58, 72, 91, 107, 113.
[206] L’atto di vendita, datato 1504 gennaio 13, si trova in ASMi, Fondo Acque parte antica, cart. 853, insieme a molti altri istrumenti, relativi ai secoli XVI-XVIII, riguardanti la storia successiva della roggia Triulza ed attestanti per lo più controversie fra i diversi utenti delle acque. Nel numero dei contendenti figura spesso S. Felice. Le carte provenienti direttamente dal tabularium del monastero ed aventi come oggetto le acque della roggia sono invece conservate in ASMi, Fondo Religione parte antica, cart. 5984. Si tratta comunque di un materiale estremamente scarso se paragonato con quello relativo all’ente pavese conservato nella cartella 853. Numerosi regesti di documenti relativi alla roggia Triulza sono presenti nel Registro dell’Archivio di Scritture di cui alla nota 202.
[207] Cf. nota precedente.
[208] Numerosissime furono le controversie relative alla roggia Triulza che S. Felice affrontò nei secoli XVI-XVIII. In particolare, nel periodo che a noi interessa, era in atto una vertenza con la famiglia Arconati.
[209] Rispettivamente regesti nn. 28 e 168 e regesti nn. 7, 29, 31, 33, 34, 37, 53, 61, 119, 121, 152, 162.
[210] Nn. 7, 29 e 152.
[211] Per esempio, c. 1v : “La notta del contenuto delle scritture in carta pecora vedute è di quelle che ci fanno per detto monastero sono le qui scrite.”
[212] Proprio il doc. n. 20 è l’ultimo esemplare prodotto in Pavia; cf. BARBIERI, Notariato, p. 80.
[213] Cf. BARBIERI, Notariato, pp. 50, 78.
[214] Cf. BARBIERI, Notariato, p. 145 ss.
[215] Doc. n. 82, per il quale cf. anche BARBIERI, Notariato, p. 145.
[216] Cf. CHITTOLINI, Un problema aperto, pp. 355-393.
[217] Cf. PROSDOCIMI, Il diritto ecclesiastico, pp. 164-16.
[218] In questi documenti ricorre costantemente la formula “quia erit masima utilitas dicti monasterii” o altre frasi analoghe. È da notare che tutti e tre i trattati di cui si dà notizia nell’edizione sono preliminari ad investiture perpetue: era infatti questa una delle tipologie più “a rischio” per l’integrità dei beni ecclesiastici.
[219] Cf. CAU, La data cronica, pp. 55-57.
[220] Cf. docc. nn. 9 e 10.
[221] Doc. n. 16.
[222] Cf. doc. 112 e ss.
[223] BARBIERI, Notariato, pp. 81-123. Sull’evoluzione delle notizie dorsali nei secoli IX-XII e sull’origine delle imbreviature cf. invece PRATESI, I “dicta” (per quanto riguarda l’area romana), CENCETTI, La “rogatio” (relativo all’area bolognese) e, più recentemente, CAU, I documenti privati, che esamina il fenomeno nel bergamasco, nonché ANSANI, Le carte di Morimondo, pp. XLVIII-LII, per il territorio milanese.
[224] Docc. nn. 70, 88, 90, 108.
[225] Norme per le pubblicazioni, pp. VII-XXIV.
[226] PRATESI, Una questione di metodo, pp. 312-33. Cf. anche Progetto di norme, pp. 491-503; Normes internationales.
[227] Fra tutti ricordo OLIVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda e Dizionario di toponomastica piemontese; Stato del clero della Diocesi di Pavia; VIGOTTI, La diocesi di Milano alla fine del secolo XIII; BOSELLI, Toponomastica pavese; CERRI, In giro per la diocesi; Cf. inoltre i riferimenti citati nelle introduzioni ai singoli documenti.